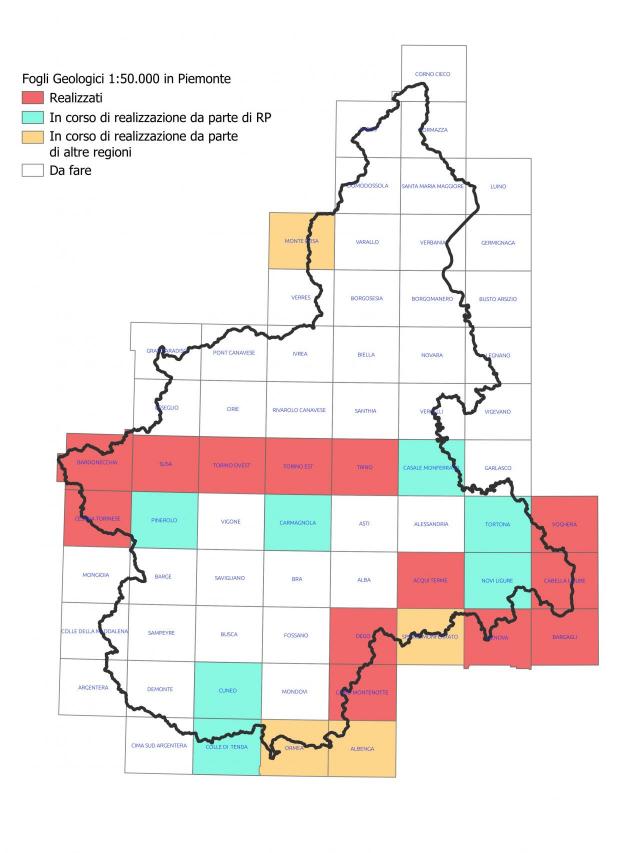PRUBAI - Programma di finanziamento per le annualità 2024-2025
Per l’attuazione del nuovo Piano di gestione dei rifiuti urbani è stato avviato, con la DGR n. 27-7845 del 04/12/2023, un nuovo Programma di finanziamento per le annualità 2024-2025: che prevede la concessione di contributi a fondo perduto ai Consorzi di area vasta per spese di investimento finalizzate al miglioramento della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti.
Le risorse a disposizione, pari a 3,453 mln di euro, derivano dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e sono destinate a sostegno di interventi per il miglioramento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nei Comuni montani, per la riorganizzazione dei servizi di raccolta finalizzati al passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare internalizzata (almeno 15.000 abitanti residenti serviti) e interventi per la riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato in comuni già serviti da raccolta domiciliare (misurazione puntuale almeno del RUR per l’applicazione della tariffa puntuale o raccolta del rifiuto indifferenziato tramite “sacco conforme” o “sacco prepagato”).
Il bando a sportello, approvato a dicembre 2023, è aperto alla presentazione delle domande a partire dal 1/03/2024 e fino al 16/09/2024.
Le azioni finanziabili sono alcune tra quelle che il PRUBAI ha individuato quali “strumenti” per il raggiungimento degli obiettivi. I territori che hanno beneficiato negli anni precedenti di finanziamenti regionali per la riorganizzazione dei servizi di raccolta o per il passaggio a tariffa puntuale (da ultimo con la Misura 50 del Piano Riparti Piemonte, concluso il 30/11/2023) hanno conseguito risultati di raccolta differenziata e di riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato sostanzialmente in linea con quanto previsto dal Piano a partire dal 2026 e dai bandi di finanziamento (RUR < 126 kg/anno pro capite).
Anche i risultati conseguiti dal CAV Torino nei quartieri serviti dalle eco-isole ad accesso controllato sono in linea, se verificati sul numero di abitanti equivalenti anziché su quello degli abitanti residenti.
Per maggiori dettagli, è possibile visitare la pagina del bando.
Per l’attuazione del nuovo Piano di gestione dei rifiuti urbani è stato avviato, con la DGR n. 27-7845 del 04/12/2023, un nuovo Programma di finanziamento per le annualità 2024-2025: che prevede la concessione di contributi a fondo perduto ai Consorzi di area vasta per spese di investimento finalizzate al miglioramento della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti.
Le risorse a disposizione, pari a 3,453 mln di euro, derivano dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e sono destinate a sostegno di interventi per il miglioramento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nei Comuni montani, per la riorganizzazione dei servizi di raccolta finalizzati al passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare internalizzata (almeno 15.000 abitanti residenti serviti) e interventi per la riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato in comuni già serviti da raccolta domiciliare (misurazione puntuale almeno del RUR per l’applicazione della tariffa puntuale o raccolta del rifiuto indifferenziato tramite “sacco conforme” o “sacco prepagato”).
Il bando a sportello, approvato a dicembre 2023, è aperto alla presentazione delle domande a partire dal 1/03/2024 e fino al 16/09/2024.
Le azioni finanziabili sono alcune tra quelle che il PRUBAI ha individuato quali “strumenti” per il raggiungimento degli obiettivi. I territori che hanno beneficiato negli anni precedenti di finanziamenti regionali per la riorganizzazione dei servizi di raccolta o per il passaggio a tariffa puntuale (da ultimo con la Misura 50 del Piano Riparti Piemonte, concluso il 30/11/2023) hanno conseguito risultati di raccolta differenziata e di riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato sostanzialmente in linea con quanto previsto dal Piano a partire dal 2026 e dai bandi di finanziamento (RUR < 126 kg/anno pro capite).
Anche i risultati conseguiti dal CAV Torino nei quartieri serviti dalle eco-isole ad accesso controllato sono in linea, se verificati sul numero di abitanti equivalenti anziché su quello degli abitanti residenti.
Per maggiori dettagli, è possibile visitare la pagina del bando.