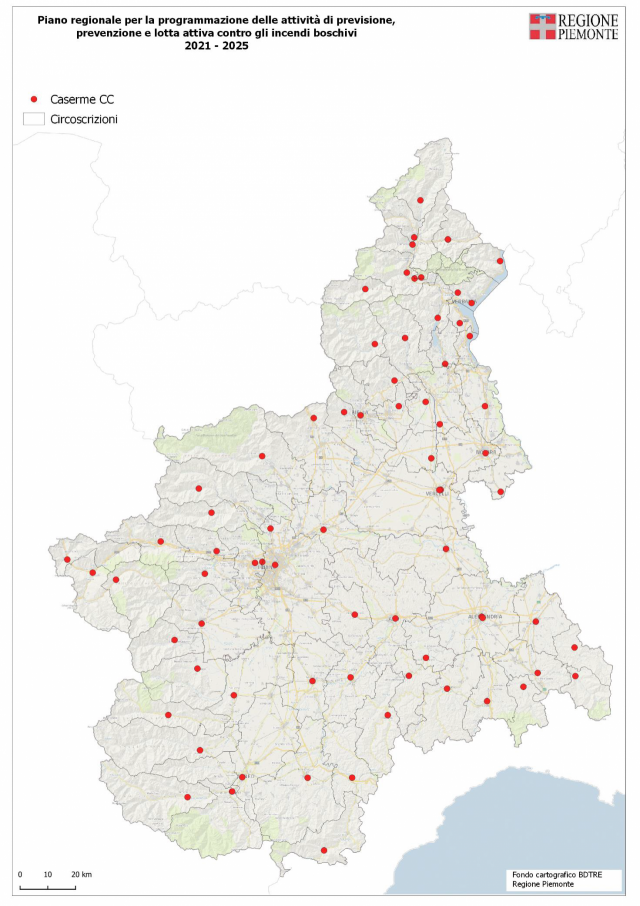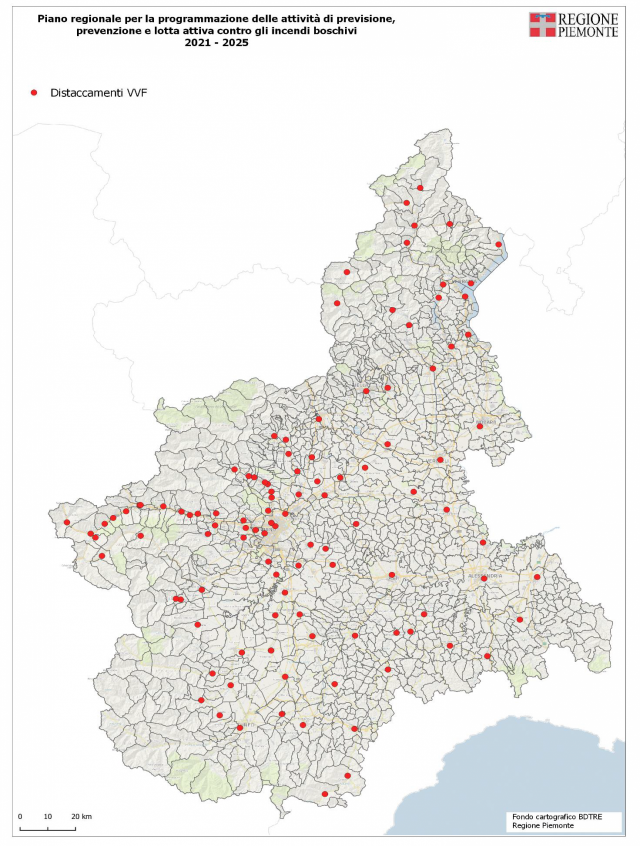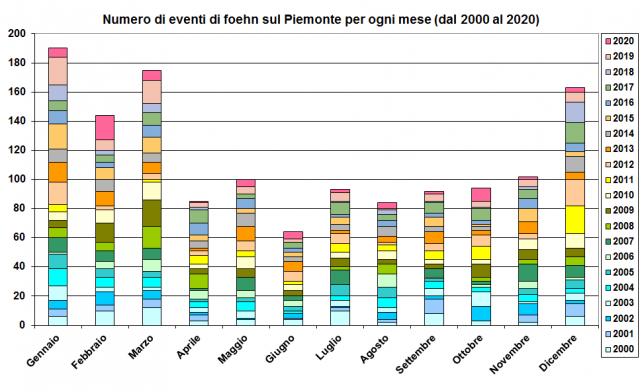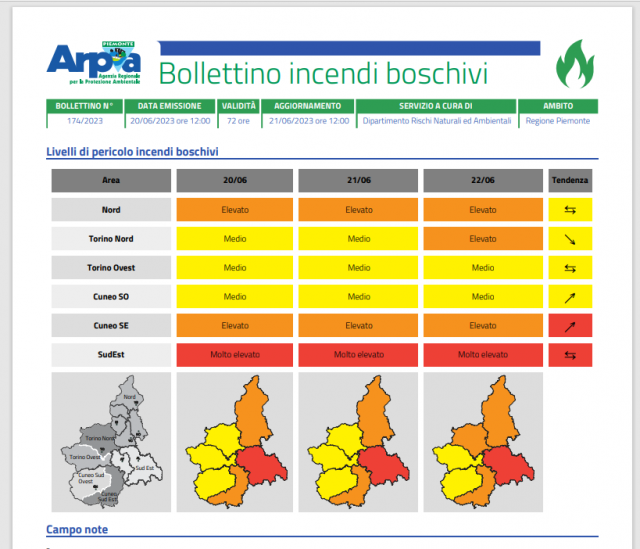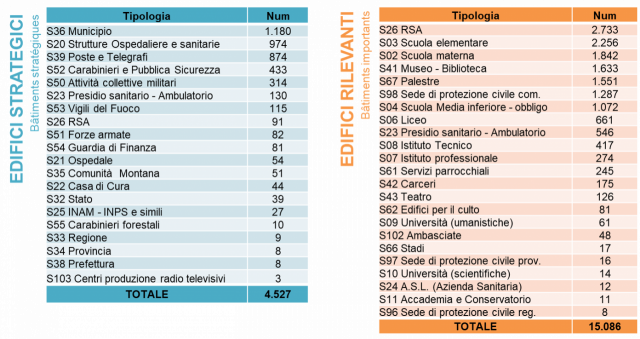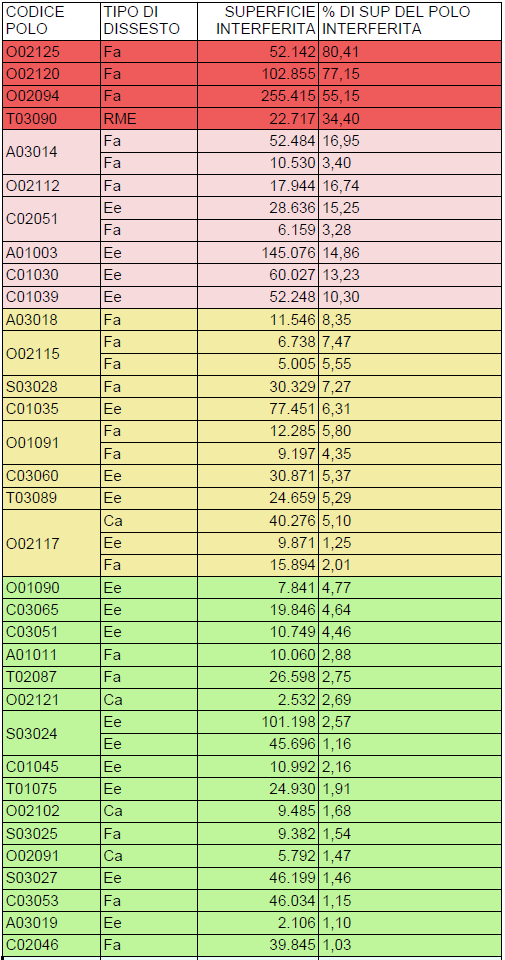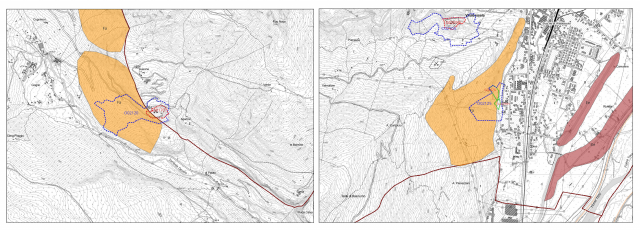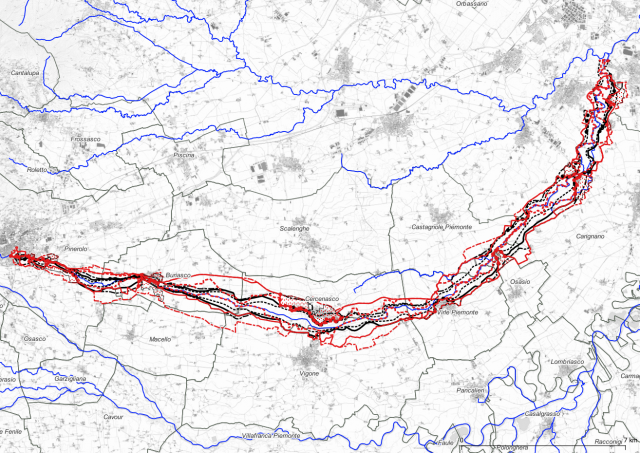Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) della Regione Piemonte costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive di cava ai sensi della legge regionale n. 23 del 17 novembre 2016 ed è volto a perseguire il corretto equilibrio tra i valori territoriali, l'attività estrattiva e il mercato di riferimento. Ai sensi della legge regionale n. 23/2016, il PRAE persegue i seguenti dieci obiettivi (art. 4):
- definire le linee per un corretto equilibrio fra i valori territoriali, quali il territorio, l’ambiente e il paesaggio, l’attività estrattiva e il mercato di riferimento;
- tutelare e salvaguardare i giacimenti in corso di coltivazione, quelli riconosciuti e le relative risorse, considerando i giacimenti minerari e l’attività estrattiva come risorse primarie per lo sviluppo socio-economico del territorio;
- valorizzare i materiali coltivati attraverso il loro utilizzo integrale e adeguato alle loro specifiche caratteristiche;
- uniformare l’esercizio dell’attività estrattiva sull’intero territorio regionale;
- orientare le attività estrattive verso un migliore equilibrio nella produzione industriale e l’ottimizzazione degli interventi ai fini del recupero e della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;
- promuovere, tutelare e qualificare il lavoro e le imprese;
- favorire il recupero di aggregati inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché l’utilizzo di materiali inerti da riciclo;
- assicurare il monitoraggio delle attività estrattive;
- favorire sinergie ambientali e economiche derivanti da interventi di sistemazione e manutenzione delle aste fluviali e dei bacini idroelettrici;
- fornire indicazioni per l’approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere pubbliche.
Le fasi della redazione e dell’approvazione del PRAE sono normate dall’art. 5 della l.r.. 23/2016, e il PRAE è stato redatto in coerenza con gli indirizzi di programmazione e strategici del Documento Programmatico di Piano, inquadrando i seguenti tre comparti estrattivi:
- Comparto I: aggregati per le costruzioni e le infrastrutture;
- Comparto II: pietre ornamentali;
- Comparto III: materiali industriali.
La prima adozione del PRAE in Giunta è avvenuta con la d.g.r. n. 81-6285 del 16/12/2022; successivamente, in riscontro alle numerose osservazioni di soggetti pubblici e privati in relazione ai Poli estrattivi del Comparto II (pietre ornamentali), che manifestavano la necessità di approfondimenti e valutazioni specifiche prima dell'adozione definitiva del PRAE, la l.r. 23/2016 è stata modificata al fine di procedere all’approvazione del PRAE per stralci successivi, pertanto il Comparto II è stato temporaneamente escluso dal piano e si è proceduto all’aggiornamento di tutti i documenti del PRAE, preparando un Piano stralcio riguardante il i Comparti estrattivi I e III. Per il Comparto II si procederà in seguito ad analisi più approfondite sulle condizioni di stabilità, vincoli paesaggistici, interazioni tra attività estrattive presenti, etc., che riguarderanno ciascuno dei poli identificati per tale comparto.
Nel mese di marzo 2024, i documenti predisposti per il PRAE – Stralcio per il primo e terzo comparto sono stati condivisi con l’Organo Tecnico Regionale e con l’Autorità di Bacino del Fiume Po per le valutazioni di competenza; in seguito alla ricezione di questi pareri, e del parere di VINCA del Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali, sono state apportate le ultime modifiche ai documenti di piano, riassunte nella “Relazione di sintesi della revisione del progetto di piano”. Nel mese di ottobre 2024 è stata sottoposta alla Giunta la documentazione di piano per l’adozione definitiva, e il PRAE – Stralcio per il primo e terzo comparto è stato adottato con D.G.R. n. 20-525 del 16 dicembre 2024.
Il PRAE – Stralcio per il primo e terzo comparto è attualmente in iter di approvazione presso il Consiglio Regionale, e nel mese di aprile 2025 sono iniziati i lavori delle Commissioni consiliari in merito al piano.
Gli obiettivi correlati al Comparto II – Pietre ornamentali sono demandati al futuro Piano stralcio, che gli sarà specificatamente dedicato.
Per una trattazione più approfondita degli aspetti sopra richiamati, si rimanda ai capitoli 3.4, 3.5 e 4.1. della Relazione generale di piano del PRAE.
Informazioni e risorse aggiuntive
Piano Regionale delle Attività Estrattive:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/attivita-estrattive/piano-regionale-delle-attivita-estrattive-prae-0
Relazione generale di piano del PRAE:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/attivita-estrattive/piano-regionale-delle-attivita-estrattive-prae-adozione-2024