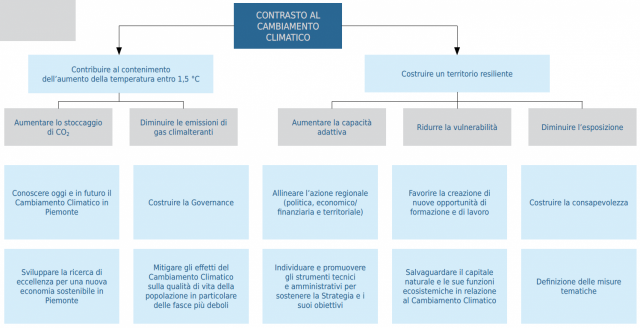La transizione energetica contribuisce a ridurre le emissioni climalteranti e le emissioni inquinanti, ad assicurare energia a prezzi ragionevoli, a ridurre le povertà energetiche, a creare nuove opportunità di crescita e occupazione, a garantire una maggiore sicurezza dell’approvvigionamento energetico e a ridurre la dipendenza
dalle importazioni dai territori limitrofi.
Le priorità di intervento di questa Macro Area Strategica sono pertanto: la riduzione dei consumi, l’aumento dell’efficienza energetica, la sostituzione progressiva delle fonti fossili con fonti rinnovabili, la promozione e facilitazione della conversione dei trasporti e della mobilità in chiave più sostenibile e un cambio di paradigma nell’organizzazione della generazione elettrica e da un modello centralizzato ad un modello di generazione distribuita. Questi assi, unitamente alla ricerca che accompagna trasversalmente molte altre tematiche, sono i caposaldi della transizione energetica ai quali il Piemonte deve tendere.
Le "direttrici" della transizione per le politiche energetiche
Riduzione dei consumi con interventi prioritari di efficientamento nel settore civile e dei trasporti
Nel settore privato e residenziale, occorrerà valutare i target di efficientamento che verranno raggiunti grazie al “super bonus” e ai nuovi criteri costruttivi obbligatori che impongono l’obbligo di costruire edifici a energia quasi zero. Per il settore industriale/produttivo, che ha già dovuto subire una significativa riduzione dei propri consumi, il target al 2030 prevede il mantenimento del livello raggiunto, pur prevedendosi una ripresa dell’economia all’orizzonte temporale dato da qui al 2030.
Costruzione di un mix bilanciato di fonti rinnovabili
Verrà privilegiata l’energia utile prodotta da fonti elettriche e termiche che non prevedono il ricorso a processi di combustione e che quindi non incidono sulla qualità dell’aria. Ne sono esempio: la fonte solare fotovoltaica e termica, l’idroelettrico, l’eolico e la geotermia, con le cautele derivanti dagli effetti del cambiamento climatico sulle precipitazioni e in relazione alle problematicità nel riempimento degli invasi a fini idroelettrici e di disponibilità della risorsa fisica. Per quanto riguarda l’uso di biomassa di cui il Piemonte dispone si intende intervenire con l’efficientamento dei sistemi di combustione, riducendo progressivamente le quantità totali di biomassa combusta e favorendo nel contempo un processo di qualificazione della risorsa forestale utilizzata, mediante l’organizzazione di una filiera corta.
Il passaggio dalla generazione elettrica centralizzata a quella distribuita
in relazione a fonti rinnovabili legate al territorio, fortemente geo-referenziate e in relazione al consumo locale, attraverso l’implementazione del concetto di prosumer, secondo cui, il nuovo cliente finale sarà in grado di autoprodurre l’energia che gli serve e di immagazzinare/stoccare le eccedenze (differendone temporalmente il consumo) per cederle ad altri consumatori attraverso l’adozione di sistemi intelligenti di programmazione locale di autoproduzione e consumo (auto-consumatori che agiscono collettivamente e comunità energetiche) costituirà un altro degli elementi qualificanti del processo di transizione. Si evidenzia come il Piemonte già dal 2018 disponga di una legge regionale (l.r. n. 12/2018) con cui vengono promosse, a titolo sperimentale e in attesa del recepimento della Direttiva RED II, le comunità energetiche.