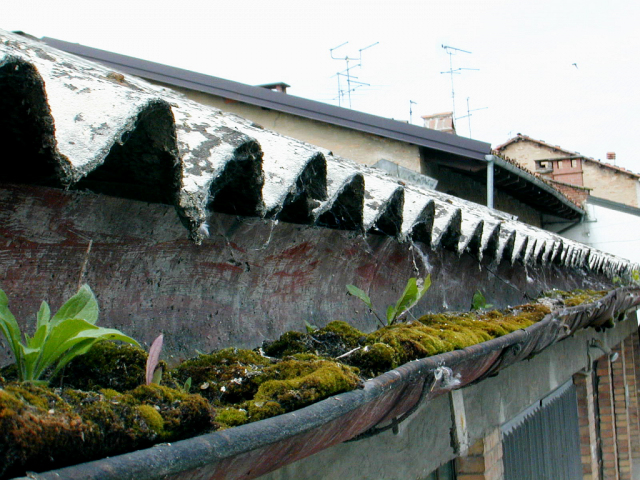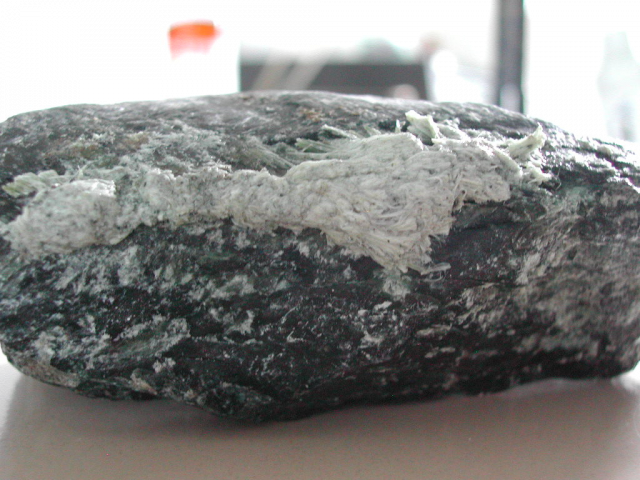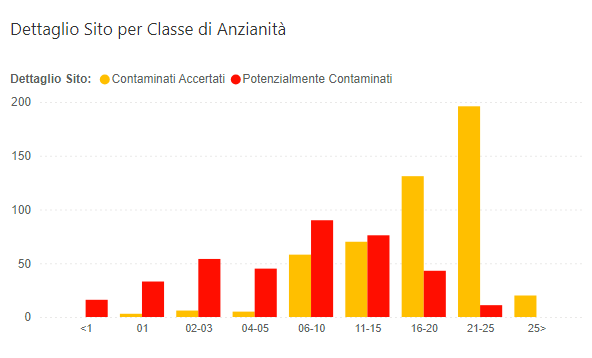La regolamentazione della produzione e gestione dei rifiuti è contenuta nella Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
L'obiettivo della direttiva è stabilire un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti nell’Unione europea, concepito in modo da proteggere l’ambiente e la salute umana, sottolineando l’importanza di adeguate tecniche di gestione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, volte a ridurre le pressioni sulle risorse e a migliorarne l’uso.
La direttiva stabilisce una gerarchia dei rifiuti:
- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- altro recupero (per esempio recupero di energia);
- smaltimento.
Conferma il «principio chi inquina paga», in base al quale i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale, introduce il concetto di «responsabilità estesa del produttore» e distingue tra rifiuti e sottoprodotti.
Prevede inoltre che la gestione dei rifiuti deve essere effettuata senza creare alcun pericolo per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna, senza comportare inconvenienti da rumori o odori, e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse e che i produttori o detentori di rifiuti devono trattarli in proprio o consegnarli a un operatore ufficialmente riconosciuto. In entrambi i casi devono essere autorizzati e sono sottoposti a ispezioni periodiche.
Le autorità nazionali competenti sono tenute a istituire piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti.
Condizioni particolari si applicano a rifiuti pericolosi, oli usati e rifiuti organici.
Introduce obiettivi di riciclaggio e di recupero da raggiungere entro il 2020 per i rifiuti domestici (50 %) e i rifiuti da costruzione e demolizione (70 %).
La normativa non riguarda taluni tipi di rifiuti, quali elementi radioattivi, materiali esplosivi in disuso, feci, acque reflue e carcasse di animali già regolamentati in norme apposite o in norme relative a settori specifici.
Nell’ambito di un pacchetto di misure sull’economia circolare, la Direttiva (UE) 2018/851 modifica la direttiva 2008/98/CE.
Stabilisce i requisiti operativi minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore, i quali possono includere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla possibilità di riutilizzare e riciclare i prodotti e rafforza le norme relative alla prevenzione dei rifiuti.
Infatti, gli Stati membri dell’Unione devono adottare misure per:
- sostenere modelli di produzione e consumo sostenibili;
- incoraggiare la progettazione, la produzione e l’uso di prodotti che siano efficienti nell’utilizzo delle risorse, durevoli, riparabili, riutilizzabili e che possano essere aggiornati;
- concentrarsi sui prodotti contenenti materie prime essenziali per evitare che tali materiali diventino rifiuti;
- incoraggiare la disponibilità di parti di ricambio, manuali di istruzioni, informazioni tecniche o altri mezzi che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
- ridurre la produzione di rifiuti alimentari come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % lo spreco alimentare globale pro capite a livello della vendita al dettaglio e dei consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le filiere di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;
- promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti;
- fermare la produzione di rifiuti marini.
Stabilisce altresì nuovi obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti urbani: entro il 2025 dovrà essere riciclato almeno il 55 % dei rifiuti urbani in peso.
Tale obiettivo salirà al 60 % entro il 2030 e al 65 % entro il 2035.
Gli Stati membri devono anche istituire, entro il 1° gennaio 2025, la raccolta differenziata dei materiali tessili e dei rifiuti pericolosi prodotti dalle famiglie e garantire che, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici siano raccolti separatamente o riciclati alla fonte (ad esempio, mediante compostaggio).
La direttiva evidenzia anche esempi di incentivi per applicare la gerarchia dei rifiuti, quali ad esempio gli oneri per il conferimento in discarica e l’incenerimento e i sistemi di pagamento in base al consumo.