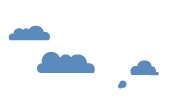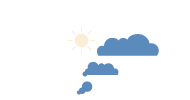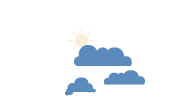A conclusione di un lungo iter di formazione, volto a garantire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati e a realizzare uno strumento sempre più completo, comprensibile ed efficace, il consiglio regionale del Piemonte ha approvato, con D.C.R. 3 luglio 2017, n. 233-35836, il Piano paesaggistico regionale (Ppr), strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, realizzato d’intesa con il ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo.
Le politiche di pianificazione territoriale e paesaggistica possono essere considerate come vere e proprie politiche di sviluppo regionale e costituiscono un elemento di notevole rilevanza per il consolidamento delle culture e delle economie locali, così come per il rafforzamento della competitività e dell’attrattività della regione rispetto a più ampi contesti europei e internazionali.
Le nuove esigenze e le nuove opportunità legate a tali politiche hanno in particolare trovato riscontro nella Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000 da 45 Paesi membri del Consiglio d’Europa nonché, per quanto riguarda l’Italia, nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004).
Nello spirito della Convenzione europea, il Ppr non si limita a riconoscere e proteggere gli ambiti di eccezionale pregio e bellezza, ma si rivolge all’intero territorio regionale, comprensivo dei paesaggi della quotidianità, che rappresentano i contesti di vita e lavoro delle persone contribuendo a determinarne la qualità e che vanno quindi difesi dalle trasformazioni incontrollate, e di quelli compromessi o degradati, dei quali promuove il recupero e la riqualificazione.
L’azione di tutela del Piano, per essere pienamente efficace, necessita del fondamentale contributo degli enti locali; a seguito dell’approvazione, infatti, i Comuni sono chiamati ad avviare il processo di revisione dei propri strumenti urbanistici, al fine di recepire le previsioni del Ppr. Oltre alle essenziali finalità di regolamentazione, il Piano mira a diffondere una maggiore consapevolezza e attenzione nei confronti del paesaggio, inteso come patrimonio comune da proteggere e valorizzare, e ad accrescere la sensibilità dei cittadini verso gli obiettivi di tutela. Anche per questo il Piano affianca aspetti di natura strategica e progettuale a quelli più strettamente normativi.
Gli obiettivi del Piano
Il Ppr costituisce atto di pianificazione generale regionale improntato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali. Definisce modalità e regole volte a garantire che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato. A tale scopo promuove la salvaguardia, la gestione e il recupero dei beni paesaggistici e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati.
Dalle cinque strategie del Ppr discendono 26 obiettivi generali, che sono comuni a Piano paesaggistico e Piano territoriale. Le finalità particolari e le strategie operative per gli aspetti paesaggistico-ambientali sono invece in gran parte differenti da quelle territoriali, in relazione ai temi specifici e agli interessi diversificati che Ppr e Ptr si trovano ad affrontare: il quadro degli obiettivi specifici, pur mantenendo un reciproco coordinamento, è pertanto differenziato per i due strumenti.
Il quadro degli obiettivi specifici costituisce il riferimento per gli aspetti di qualità paesaggistica da individuare in ciascun ambito di paesaggio. A tal fine, nell’allegato B alle Norme di attuazione sono riportati gli obiettivi specifici di maggiore rilevanza per la qualità paesaggistica di ciascun ambito, accompagnati dalle azioni strategiche più opportune per le caratteristiche e le dinamiche di ciascuna parte di territorio.
Il significato del Piano paesaggistico
Il Piano paesaggistico costituisce strumento di pianificazione sovraordinata e prevalente secondo la legislazione nazionale sul paesaggio, che prevede la redazione di un piano esteso a tutto il territorio regionale da predisporre d’intesa tra Regione e Ministero.
Al di là degli obblighi normativi, il piano costituisce presa di coscienza da parte di una comunità del valore del proprio territorio; il paesaggio rappresenta infatti l’espressione della forma di un territorio nel quale si identifica la sua popolazione, in relazione alle dinamiche ambientali, naturali, storiche, culturali, frutto delle trasformazioni operate dall’uomo nel tempo, che ne hanno plasmato le caratteristiche percettive dalla sua genesi fino a oggi.
Il piano riconosce questi aspetti e si pone come strumento di conoscenza, di regolazione, di pianificazione e programmazione, per garantire la salvaguardia delle invarianti del territorio, la riqualificazione delle parti compromesse, la crescita di una coscienza comune sull’importanza dell’attenzione nei confronti del territorio, risorsa non riproducibile, in grado di garantire lo sviluppo delle comunità che lo abitano.
Le finalità del Piano paesaggistico
Il Ppr è strumento di:
- Conoscenza: costituisce un “atlante” complessivo che descrive il territorio piemontese; riconosce i valori fondamentali che lo qualificano, i suoi caratteri identitari, le principali criticità presenti; rappresenta una visione unitaria della regione alla luce delle sue componenti costitutive, delle sue principali vocazioni, delle espressioni caratteristiche che contraddistinguono la sua storia;
- Programmazione: contiene linee strategiche volte alla tutela del paesaggio e al miglior utilizzo del territorio; il Ppr ha sostenuto numerose azioni già attuate (progetti europei, progetti di valorizzazione, progetti di riqualificazione) e, nella sua parte strutturale, contiene principi e assi tematici che consentiranno nei prossimi anni di dare corso a politiche consapevoli di rigenerazione e valorizzazione del territorio, in una logica di sviluppo del Piemonte volta alla qualificazione e salvaguardia delle sue risorse, verso un’economia sostenibile e per il miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti;
- Pianificazione: i contenuti del Ppr costituiscono elemento fondante per il sistema della pianificazione territoriale provinciale e della città metropolitana, della pianificazione urbanistica dei comuni e delle loro forme associative, nonché riferimento essenziale per la definizione di strumenti di pianificazione settoriale coerenti e compatibili con le caratteristiche del territorio piemontese;
- Regolazione: contiene nella sua parte prescrittiva misure di tutela volte a tradurre i riconoscimenti di valore in disposizioni normative che incidono direttamente o indirettamente sui processi di trasformazione, finalizzate a garantire il corretto equilibrio tra sviluppo delle comunità e salvaguardia dei principali ambiti di pregio paesaggistico.
La visione strategica
Il Ppr affronta i temi della tutela del territorio e della qualità paesaggistica delle trasformazioni sia direttamente attraverso i propri contenuti normativi, sia promuovendo programmi, piani e progetti strategici volti alla valorizzazione integrata del territorio, a regia regionale o promossi da soggetti diversi (pubblici e privati), nonché con la realizzazione di approfondimenti tematici, attraverso la definizione di studi e analisi di accompagnamento al processo di attuazione del Ppr.
Il Ppr sostiene politiche e iniziative di livello sovra locale che mirano a uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio, in particolare relativamente ai seguenti temi:
- valorizzazione del patrimonio paesaggistico piemontese;
- implementazione della rete di connessione paesaggistica;
- contenimento del consumo di suolo;
- salvaguardia attiva dei paesaggi agrari;
- definizione di criteri e modalità specifici per la qualificazione dei sistemi urbani e periurbani in termini edilizi, urbanistici e della funzionalità ecosistemica del territorio;
- implementazione delle infrastrutture verdi e dei servizi ecosistemici;
- inserimento paesaggistico dei manufatti specialistici e degli impianti tecnologici o di produzione di energia e riqualificazione delle aree dismesse o compromesse.
Il Ppr riconosce quali strumenti di approfondimento di queste tematiche, i seguenti programmi e progetti strategici, già attuati o in corso di attuazione:
- i progetti relativi ai siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco e delle Riserve della biosfera (MAB);
- la salvaguardia dei tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano;
- il progetto Corona Verde;
- i contratti di fiume e di lago;
- l’implementazione della rete ecologica regionale;
- i progetti europei finanziati con il programma di cooperazione trasnazionale “Alpine space”;
- le attività connesse al monitoraggio del consumo di suolo.
Autorizzazioni e semplificazione amministrativa
Il Ppr non introduce, in riferimento alle procedure autorizzative degli interventi ricadenti all'interno di beni paesaggistici, vere e proprie novità, che invece possono risultare di rilievo a seguito del completamento delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr stesso. Fino ad allora, infatti, i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche continueranno a verificare la conformità degli interventi proposti con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti dettate dal Piano paesaggistico. Anche dal punto di vista della semplificazione amministrativa, la conformazione degli strumenti urbanistici costituisce il requisito essenziale per lo snellimento delle procedure autorizzative; in particolare, a seguito della positiva verifica da parte del Ministero della Cultura, dell'adeguamento del piano regolatore al Ppr, il parere del Soprintendente assumerà natura obbligatoria ma non vincolante nell’ambito delle autorizzazioni di cui all’articolo 146, comma 5, del Codice.