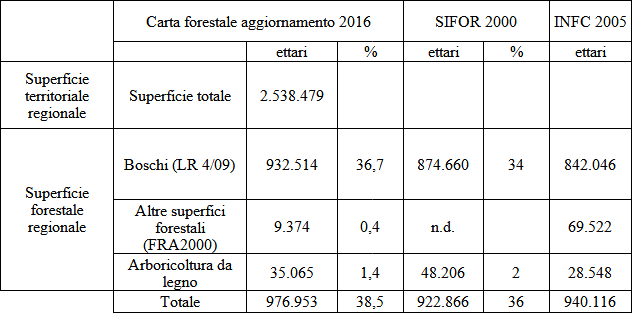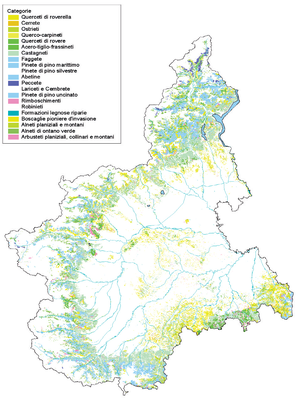La Componente M1C3 del PNRR ha l’obiettivo di rilanciare i settori economici della cultura e del turismo, che all’interno del sistema produttivo giocano un ruolo particolare, sia in quanto espressione dell’identità del Paese, sia per il peso che hanno nell’economia nazionale. Inoltre i settori del comparto sono tra quelli con la più alta incidenza di lavoro giovanile e femminile.
In relazione alle misure in ambito culturale stabilite dal PNRR, la Regione Piemonte è stata nominata con D.M. 18 marzo 2022 soggetto attuatore della misura PNRR. M1C3 Investimento 2.2. “Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”.
L’avviso nasce come risposta ad una esigenza di tutela del patrimonio rurale diffuso sul territorio, caratterizzato da una presenza capillare legata al tessuto produttivo e alle peculiarità paesaggistiche.
Molti edifici rurali, originariamente destinati a scopi abitativi (es.: casali, fattorie), produttivi (es.: case coloniche, stalle, mulini, frantoi), religiosi (chiese rurali, edicole votive), didattici (scuole rurali, fattorie didattiche) e strutture agricole hanno subito un progressivo processo di abbandono, degrado e alterazioni che ne ha compromesso le caratteristiche tipologiche e costruttive e il loro rapporto con gli spazi circostanti.
L’intervento mira pertanto a migliorare la qualità paesaggistica del territorio nazionale e favorire il trasferimento di buone pratiche, nonché l’implementazione di soluzioni innovative anche tecnologiche per migliorare l’accessibilità per persone con disabilità fisica e sensoriale. Il recupero del patrimonio edilizio rurale, ove coniugato ad interventi per migliorarne l’efficienza energetica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali. Allo stesso modo, le colture agro-forestali-pastorali di interesse storico sono caratterizzate da bassi apporti energetici esterni e da un’ottima capacità di assorbimento della CO2, spesso superiore alle foreste.
L’intervento, inoltre, restituisce alla collettività e in molti casi all’uso pubblico un patrimonio edilizio sottoutilizzato e non accessibile al pubblico; il suo recupero favorisce non solo le attività legate al mondo agricolo ma anche la creazione di servizi a beneficio della fruizione culturale e turistica, come i piccoli musei locali legati al mondo rurale che svolgono un ruolo importante nelle comunità locali promuovendo la conoscenza e la memoria.
L’investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” è pertanto finalizzato alla realizzazione di un’azione sistematica di conoscenza, tutela e valorizzazione di edifici storici rurali e del paesaggio rurale, attraverso il perseguimento dei seguenti principali obiettivi:
- Preservare i valori dei paesaggi rurali storici attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni della cultura materiale e immateriale e al mantenimento e ripristino della qualità paesaggistica dei luoghi;
- Promuovere la creazione di iniziative e attività legate ad una fruizione turistico-culturale sostenibile, alle tradizioni e alla cultura locale.
Con l’investimento M1C3 Intervento 2.2 l’importo assegnato dal MIC alla Regione Piemonte ammonta ad Euro 39.494.512,07 e coinvolge oltre 300 beneficiari, in particolare persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, cui sono rivolte le azioni di sostegno. Importante è il ruolo della Soprintendenza e degli Enti Locali chiamati al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’attivazione dei progetti assegnatari di contributo.
A beneficiarne sono stati principalmente beni religiosi e beni che rappresentano varie categorie dell’architettura rurale, edifici e spazi che costituiscono testimonianze significative della storia delle comunità e dei sistemi rurali, nonché delle rispettive economie agricole tradizionali e dell’evoluzione del paesaggio. I progetti presentati sono volti infatti anche ad un miglioramento complessivo della qualità del paesaggio e all’attivazione di processi di valorizzazione territoriale, attraverso il potenziamento della fruizione culturale-turistica di tale patrimonio e l’integrazione con reti, itinerari, sistemi culturali.
I criteri di assegnazione hanno previsto il sostegno di progetti caratterizzati da una forte attenzione alla sostenibilità, collocati in territori di tutela paesaggistica e/o legati a piani o iniziative di carattere sovraregionale, come i cammini religiosi (Via Francigena) o i riconoscimenti UNESCO. In particolare, numerosi progetti finanziati appartengono ai territori compresi nell’area della Riserva della Biosfera UNESCO del Monviso e nelle aree del sito Patrimonio Mondiale dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, ma non mancano anche numerosi interventi nei territori appartenenti ad altri riconoscimenti UNESCO.
Parchi e giardini storici
Il progetto rientra nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.3 "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici". L'obiettivo principale è rafforzare i valori culturali, storici e ambientali dei parchi e giardini, favorendo una corretta conservazione e valorizzazione, anche in ottica turistica. In particolare, si punta a contrastare il decadimento urbano, ristabilire le identità condivise dei luoghi e creare nuove opportunità per il rilancio delle economie locali, oltre che a migliorare la gestione e la conservazione dei beni culturali.
L'investimento M1C3 I2.3 prevede un’importante azione destinata al censimento, al restauro e alla valorizzazione di Parchi e Giardini storici, nell’ambito della quale è previsto uno specifico “Progetto di catalogazione di parchi e giardini storici”. Il progetto intende avviare un processo di individuazione, quantificazione e descrizione dei parchi e giardini storici, finalizzato alla catalogazione (tramite la compilazione della scheda PG 4.01, appositamente predisposta dall’ICCD – Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione), per favorire l’implementazione del Catalogo generale dei beni culturali. Sul totale nazionale di 300.000.000 euro per la Misura M1C3-I2.3, le risorse destinate all’attività di catalogazione dei parchi e giardini storici sono pari a 3.000.000 euro, di cui 2.511.300 di euro assegnati alle Regioni e Province Autonome per l’attuazione del “Progetto di catalogazione di parchi e giardini storici”. Delle risorse complessive, il Piemonte risulta assegnatario, con DSG n. 455 del 22/04/2024, di 120.000 euro per il finanziamento della catalogazione di n. 400 parchi e giardini storici siti sul territorio regionale, da completarsi entro il 31 dicembre 2025.