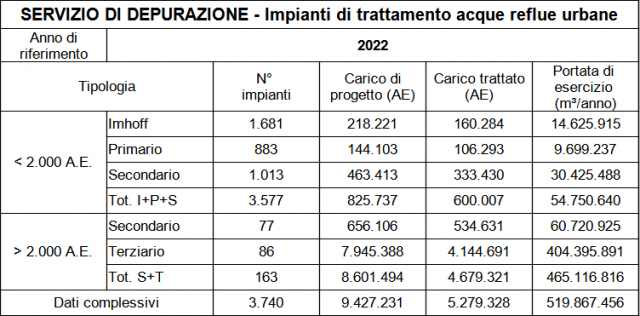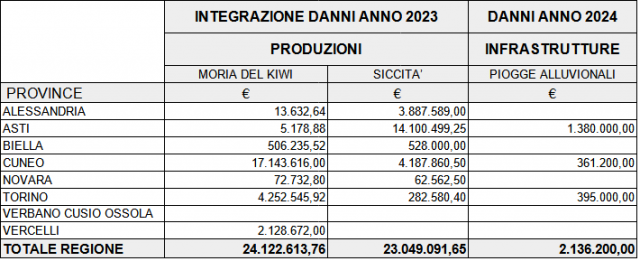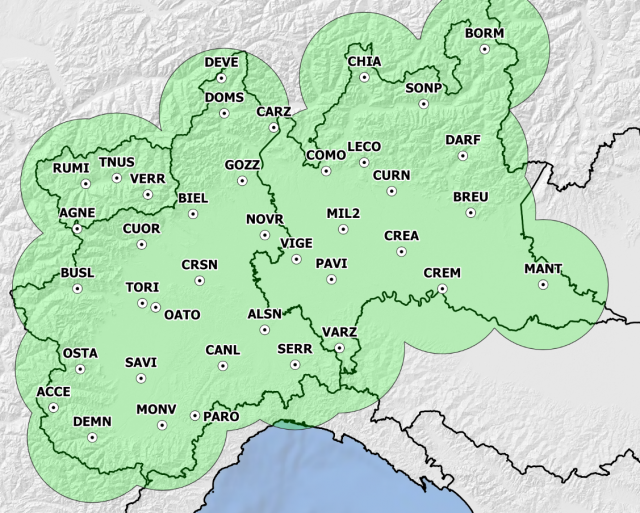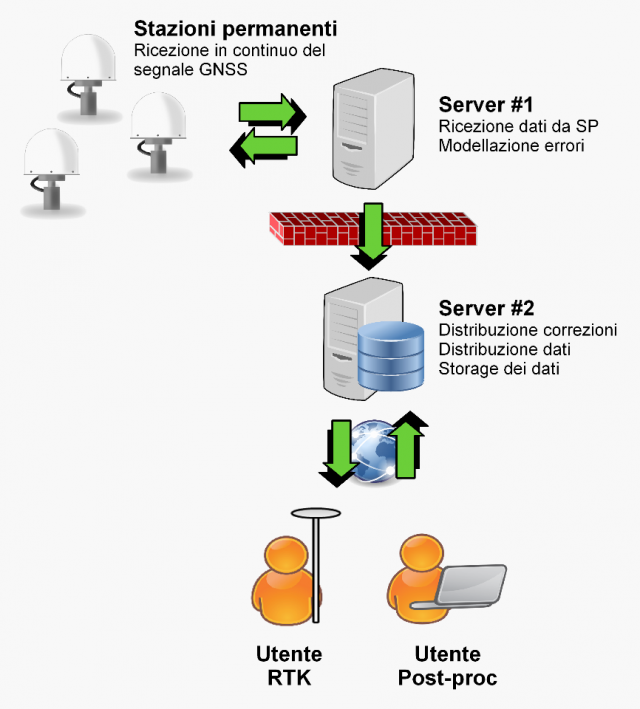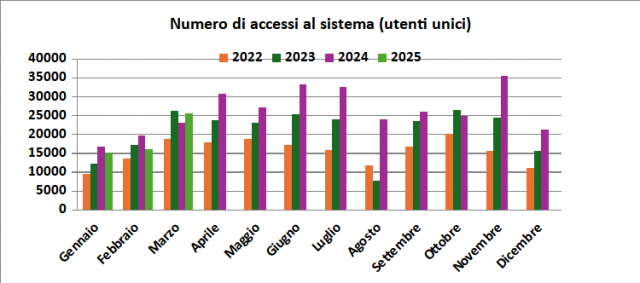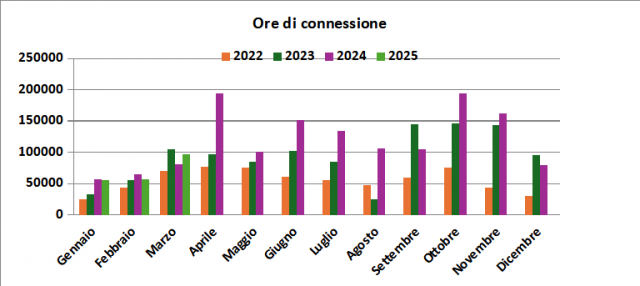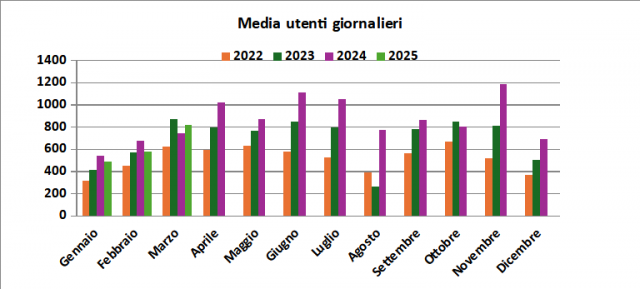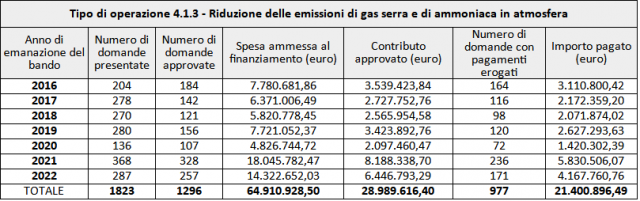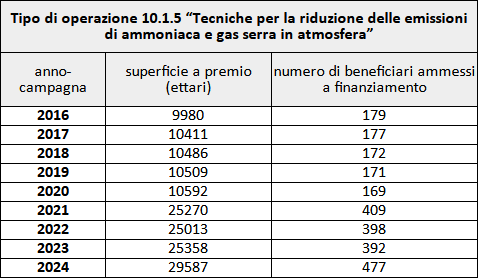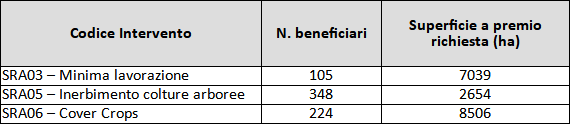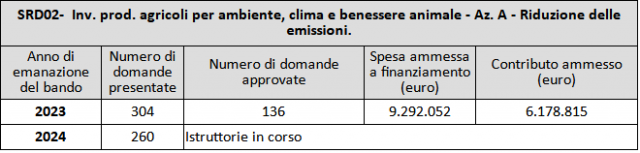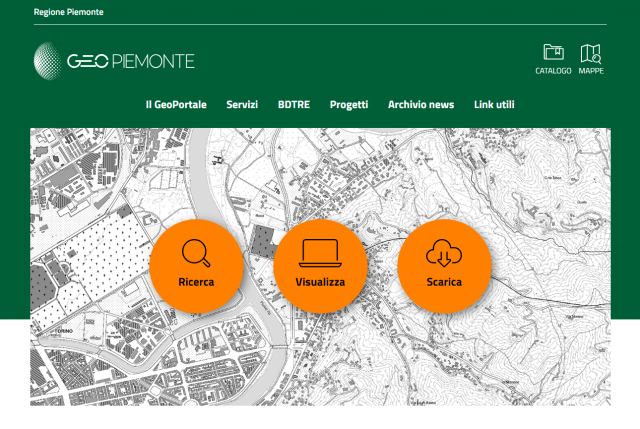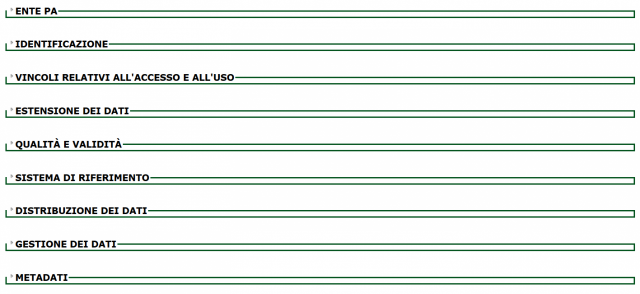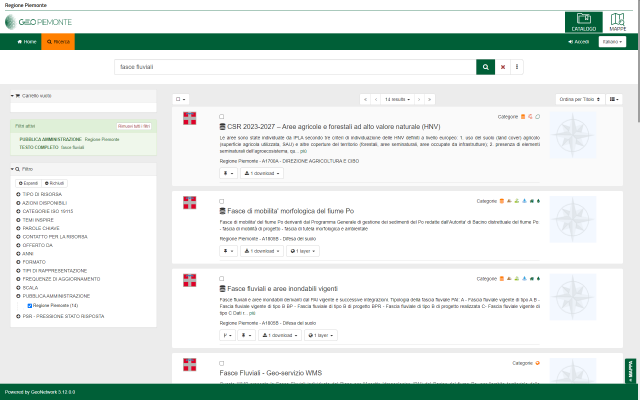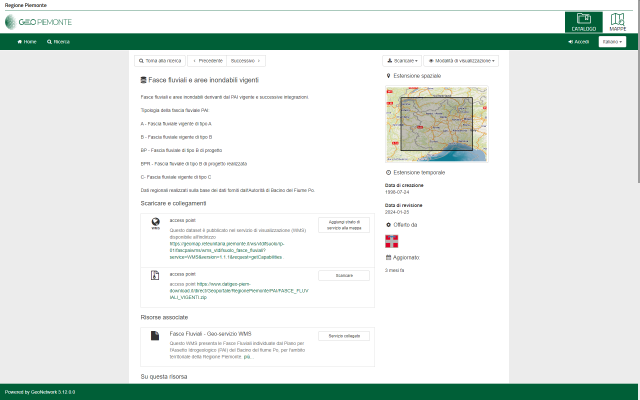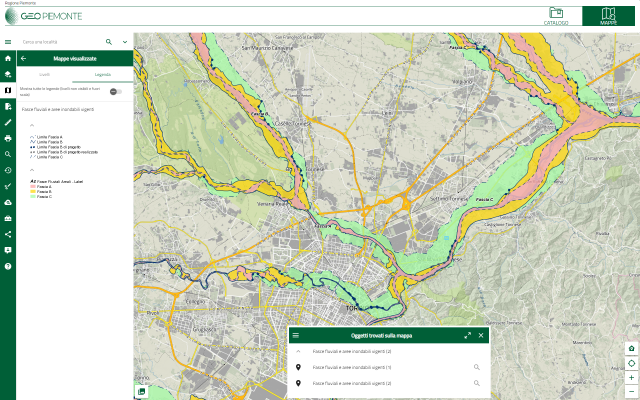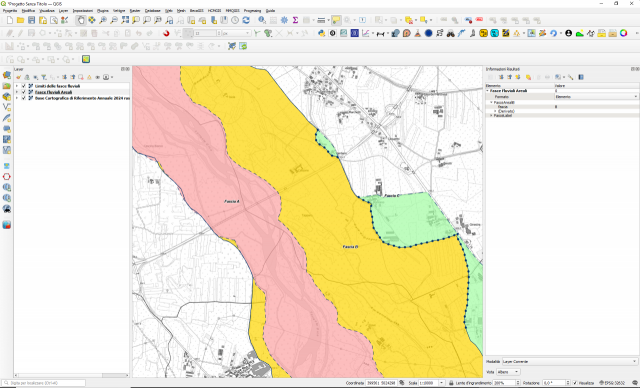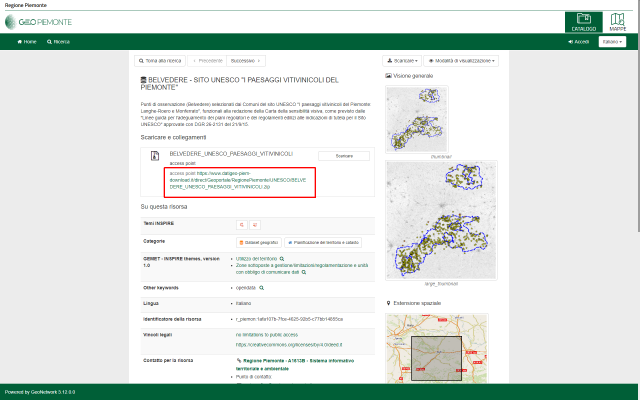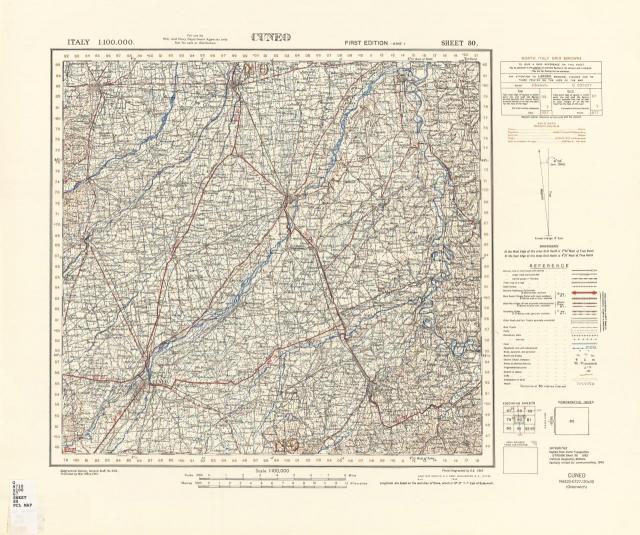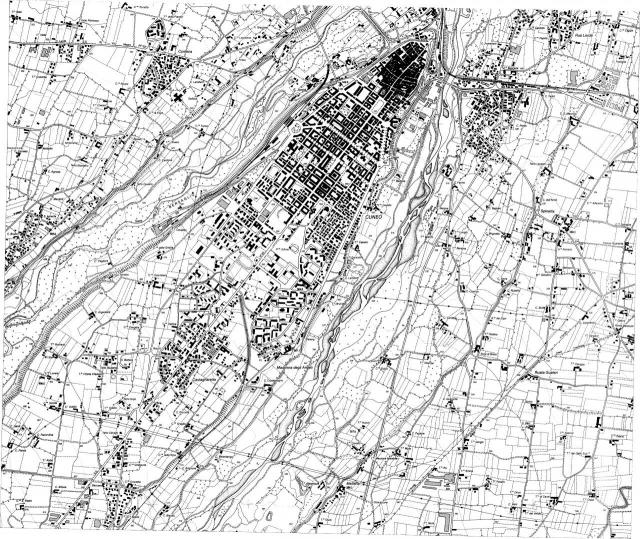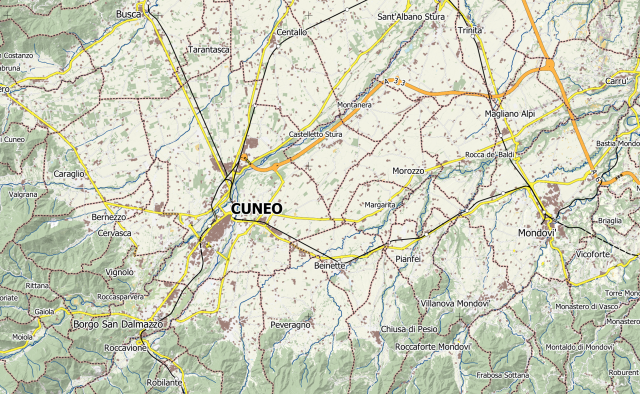Ciclovia turistica VenTo
Dopo la sigla del primo protocollo d’intesa tra MIT, il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBACT) e le Regioni interessate (28 luglio 2016), per la progettazione e realizzazione della ciclovia turistica VEnTO da Venezia a Torino, si è siglato un ulteriore accordo tra le 4 Regioni interessate e il Politecnico di Milano, sancendone il ruolo di coordinatore scientifico per la progettazione (ottobre 2016). Successivamente, tramite Regione Lombardia (capofila di progetto) è stata affidata la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intero percorso, finanziato dal Ministero e consegnato il 30 aprile 2019, mentre il 2 agosto 2019 si concludeva la conferenza dei servizi preliminare per la valutazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Il 18 aprile 2019 era stato approvato un nuovo protocollo d’intesa tra il MIT e le Regioni interessate (per equiparare tutte le ciclovie strategiche di interesse nazionale).
Successivamente, ciascuna regione, su indicazione del MIT, ha individuato un lotto prioritario di intervento su cui si procederà alla progettazione definitiva/esecutiva e quindi alla realizzazione (in base alle risorse stanziate per ciascuna). La Regione Piemonte ha individuato il tratto Chivasso-Trino Vercellese, facendo coincidere il tratto iniziale (Chivasso-Borgo Revel) con la Ciclostrada del Canale Cavour.
Dopo numerosi incontri la Regione Piemonte ha affidato ad AIPO la successiva progettazione, realizzazione e gestione del Progetto Vento (essendo il tracciato per la maggioranza della sua estensione su tratti arginali del fiume Po), come hanno fatto anche la Regione Lombardia ed Emilia-Romagna. È stata anche modificata la legge istitutiva di AIPO andando ad ampliarne le competenze e I ruoli dello stesso.
Ad oggi il tratto da Chivasso (TO) a Trino Vercellese (VC) di 43Km ha il progetto definitivo in itinere, con un finanziamento di 4,8 M€ per la ciclovia a cui si aggiungono 2,9 M€ per la costruzione del nuovo ponte stradale sulla Dora Baltea di 1,5 Km, il cui progetto esecutivo in itinere è gestito dalla Città Metropolitana di Torino; il tratto di superamento della centrale nucleare di Trino (VC) di 2,5 Km è coperto da un finanziamento di 0,5 M€ derivanti dagli oneri di compensazione ambientale per la dismissione della centrale nucleare ed ha il progetto esecutivo in itinere, mentre l’ultimo tratto da Trino Vercellese (VC) a Valenza (AL) di 38 Km ha un finanziamento di 9,3 M€ derivanti dal PNRR (D.M. 4/2022) con il progetto definitivo in itinere. La fine dei lavori è prevista per il 2026.
Dopo la sigla del primo protocollo d’intesa tra MIT, il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBACT) e le Regioni interessate (28 luglio 2016), per la progettazione e realizzazione della ciclovia turistica VEnTO da Venezia a Torino, si è siglato un ulteriore accordo tra le 4 Regioni interessate e il Politecnico di Milano, sancendone il ruolo di coordinatore scientifico per la progettazione (ottobre 2016). Successivamente, tramite Regione Lombardia (capofila di progetto) è stata affidata la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intero percorso, finanziato dal Ministero e consegnato il 30 aprile 2019, mentre il 2 agosto 2019 si concludeva la conferenza dei servizi preliminare per la valutazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Il 18 aprile 2019 era stato approvato un nuovo protocollo d’intesa tra il MIT e le Regioni interessate (per equiparare tutte le ciclovie strategiche di interesse nazionale).
Successivamente, ciascuna regione, su indicazione del MIT, ha individuato un lotto prioritario di intervento su cui si procederà alla progettazione definitiva/esecutiva e quindi alla realizzazione (in base alle risorse stanziate per ciascuna). La Regione Piemonte ha individuato il tratto Chivasso-Trino Vercellese, facendo coincidere il tratto iniziale (Chivasso-Borgo Revel) con la Ciclostrada del Canale Cavour.
Dopo numerosi incontri la Regione Piemonte ha affidato ad AIPO la successiva progettazione, realizzazione e gestione del Progetto Vento (essendo il tracciato per la maggioranza della sua estensione su tratti arginali del fiume Po), come hanno fatto anche la Regione Lombardia ed Emilia-Romagna. È stata anche modificata la legge istitutiva di AIPO andando ad ampliarne le competenze e I ruoli dello stesso.
Ad oggi il tratto da Chivasso (TO) a Trino Vercellese (VC) di 43Km ha il progetto definitivo in itinere, con un finanziamento di 4,8 M€ per la ciclovia a cui si aggiungono 2,9 M€ per la costruzione del nuovo ponte stradale sulla Dora Baltea di 1,5 Km, il cui progetto esecutivo in itinere è gestito dalla Città Metropolitana di Torino; il tratto di superamento della centrale nucleare di Trino (VC) di 2,5 Km è coperto da un finanziamento di 0,5 M€ derivanti dagli oneri di compensazione ambientale per la dismissione della centrale nucleare ed ha il progetto esecutivo in itinere, mentre l’ultimo tratto da Trino Vercellese (VC) a Valenza (AL) di 38 Km ha un finanziamento di 9,3 M€ derivanti dal PNRR (D.M. 4/2022) con il progetto definitivo in itinere. La fine dei lavori è prevista per il 2026.