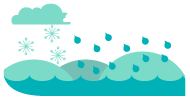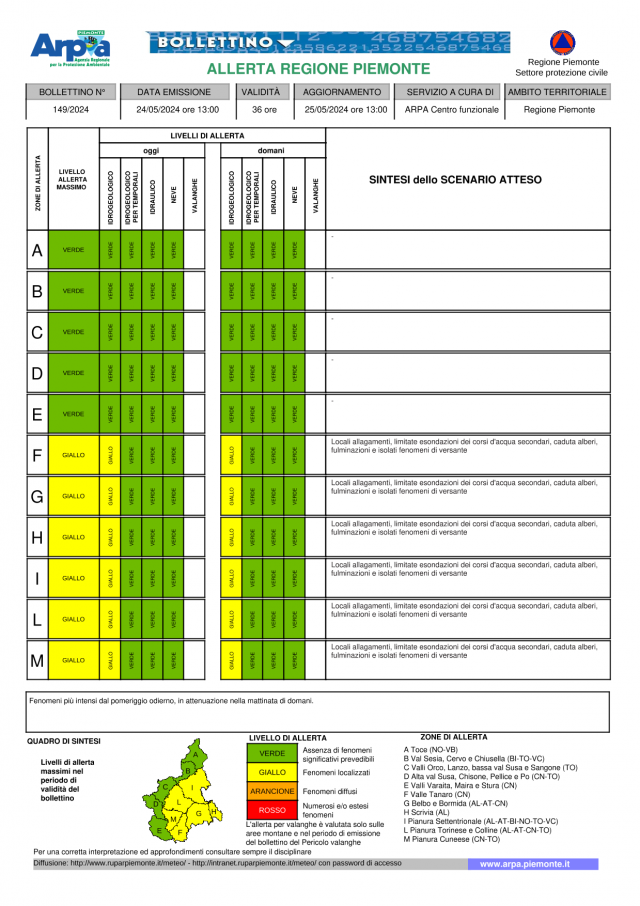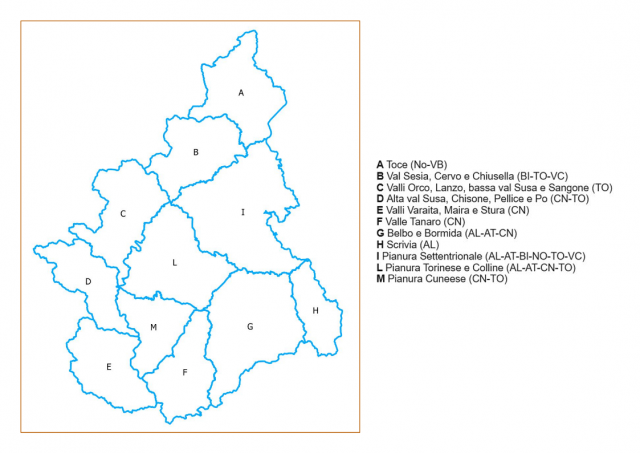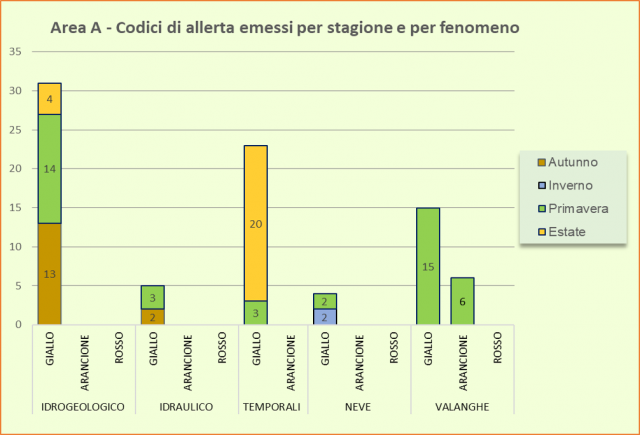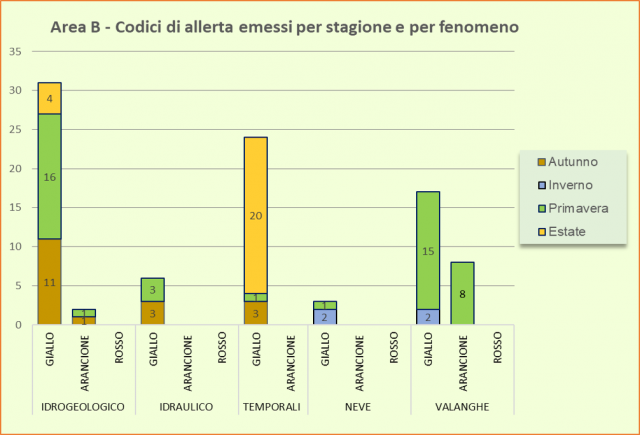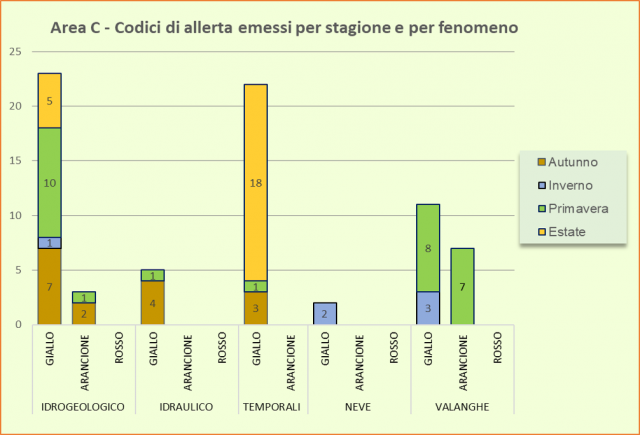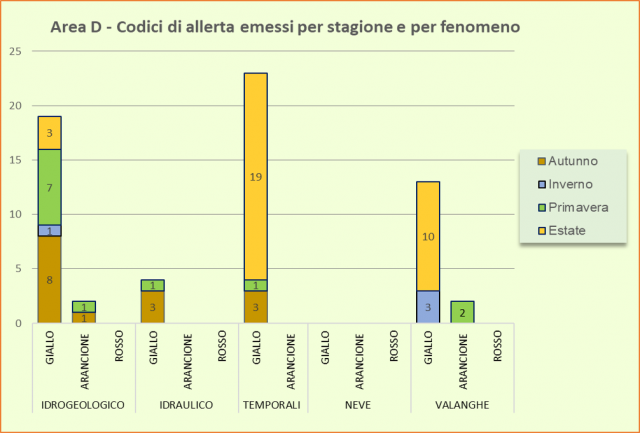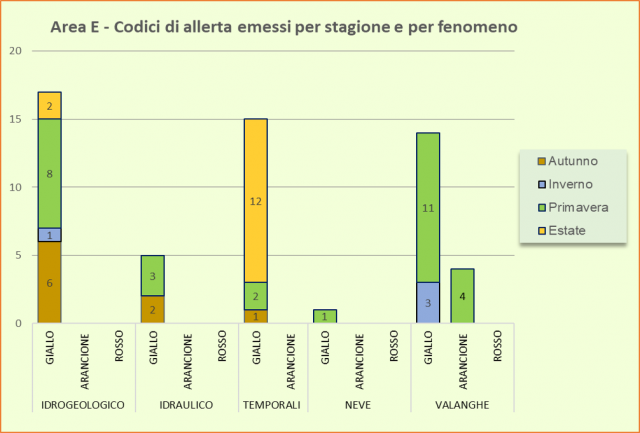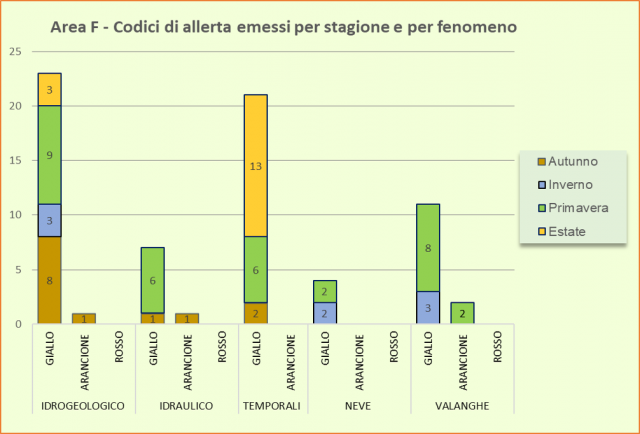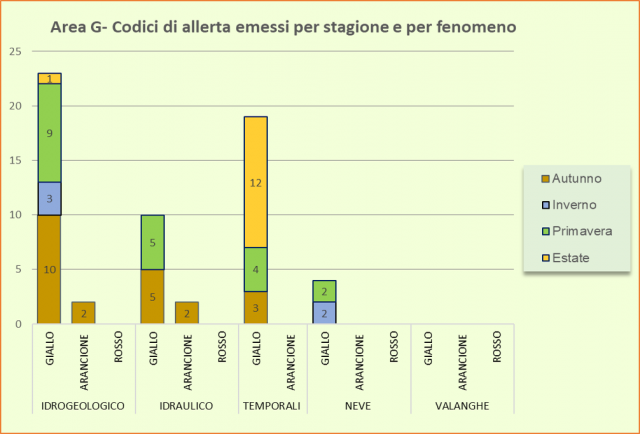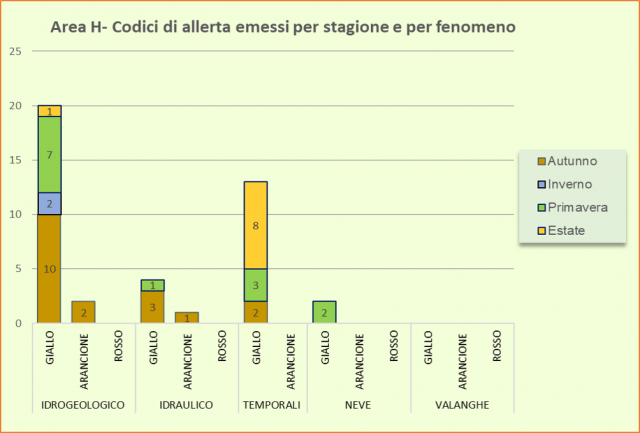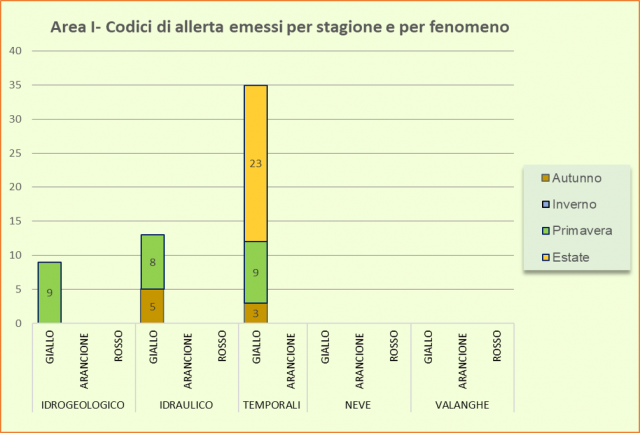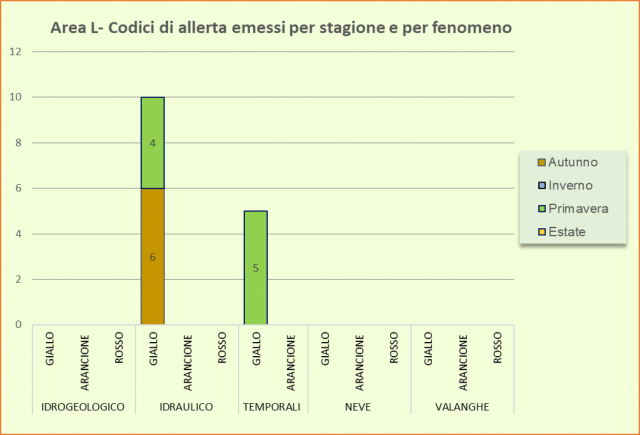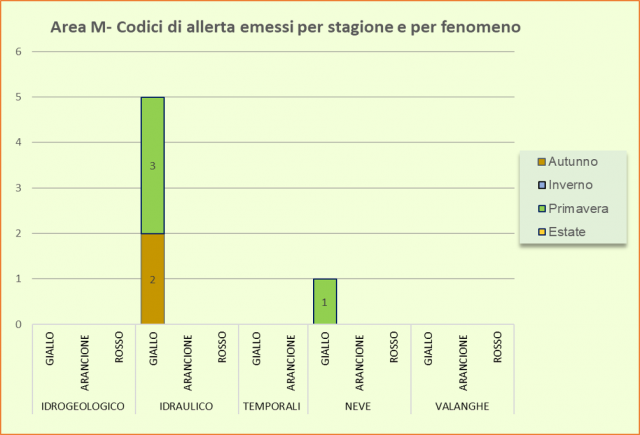Stato idromorfologico dei fiumi
Indice idromorfologido IDRAIM
Lo stato degli ecosistemi acquatici e ripariali è condizionato sia dal regime idrologico sia dalla qualità morfologica dei corpi idrici, in quanto i deflussi idrici, i processi geomorfologici del corso d’acqua e le sue condizioni di equilibrio dinamico costituiscono l’ambiente nel quale gli ecosistemi si sviluppano.
Le condizioni morfologiche, la continuità fluviale e il regime idrologico sono fattori chiave a supporto degli Elementi di Qualità Biologica nel processo di valutazione dello stato ecologico e nell’interpretazione dei pattern biologici.
La Direttiva Quadro sulle Acque prevede quindi uno specifico monitoraggio degli elementi idromorfologici che contribuiscono a confermare lo Stato Ecologico (SE) dei corpi idrici in stato Elevato, o di declassarlo a Buono.
La valutazione dello stato idromorfologico avviene tramite un Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d’acqua o l'indice IDRAIM, definito dall’analisi combinata di due indicatori: l’Indice del Regime di Alterazione idrologica (IARI) e l’Indice di Qualità Morfologica (IQM), che nel complesso valutano le alterazioni idromorfologiche rispetto a condizioni ideali di riferimento. Lo stato idromorfologico è determinato sulla base della valutazione del dato peggiore tra i due indicatori.
Nel primo ciclo di monitoraggio, terminato nel 2015, tramite l'indice IDRAIM si è giunti alla caratterizzazione e classificazione idromorfologica di 82 corpi idrici; 14 sono risultati in stato idromorfologico Elevato, 68 in stato Non Elevato.
Nel secondo ciclo di monitoraggio, terminato nel 2019, sono stati caratterizzati altri 106 corpi idrici, di questi, 13 sono risultati in stato idromorfologico Elevato, 93 in stato Non Elevato.
Nel 2024 i 6 corpi idrici indagati sono risultati in stato idromorfologico Non Elevato.
Indice IARI
L’indice valuta l'impatto di prelievi, derivazioni ad uso idroelettrico, opere di sbarramento o di invaso, opere longitudinali e variazioni del suolo sul corso d'acqua e fornisce, quindi, una misura dello scostamento del regime idrologico osservato rispetto a quello naturale, che si avrebbe cioè in assenza di pressioni antropiche.
L’indice è definito attraverso due modalità differenti, in funzione del fatto che lungo il corpo idrico in esame siano presenti una o più stazioni di misura delle portate.
A causa di fenomeni di alterazione del regime idrologico nel 2024 2 dei 6 corpi idrici monitorati hanno presentato un indice IARI Non Buono.
Indice IQM
L’indice IQM valuta la funzionalità fluviale di un corpo idrico dal punto di vista geomorfologico. Esso viene calcolato attraverso analisi e rilevamento di dati tramite ortoimmagini e sul campo. I dati raccolti ed analizzati riguardano la funzionalità dei processi geomorfologici in atto, l’artificialità - ovvero la presenza e l’impatto delle opere e degli interventi antropici, e le variazioni morfologiche subite dal fiume negli ultimi cinquant'anni. La compilazione di un’apposita scheda individua per ogni componente un valore che contribuisce alla quantificazione dell’IQM.
Nel 2024 3 dei 6 corpi idrici monitorati hanno presentato valore dell’indice Buono, 2 Sufficiente e 1 Scadente.
L’integrazione dei due indici (IARI +IQM), quindi, oltre a permettere la caratterizzazione e la classificazione idromorfologica dei corsi d’acqua, è uno strumento utile alla classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali e rappresenta una metodologia utile in studi per obiettivi specifici, come la riqualificazione fluviale, la gestione dei sedimenti o la mitigazione dei pericoli da dinamica fluviale.
| Corpo Idrico | Fiume | Classe IQM | Stato IQM | Stato IARI | Stato Idromorfologico IDRAIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 06SS1T033PI | Banna | Sufficiente | Non Elevato | Elevato | Non Elevato |
| 04SS3N148PI | Corsaglia | Buono | Non Elevato | Elevato | Non Elevato |
| 06SS3T244PI | Grana | Sufficiente | Non Elevato | Buono | Non Elevato |
| 08SS1N357PI | Ovrano | Buono | Non Elevato | Elevato | Non Elevato |
| 06SS2T976PI | Roggia Bona | Scadente | Non Elevato | Non calcolabile | |
| 01SS2N933PI | Viana | Buono | Non Elevato | Buono | Non Elevato |
Informazioni e risorse aggiuntive
Linee guida ISPRA
IDRAIM Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/idraim-sistema-di-valutazione-idromorfologica-analisi-e-monitoraggio-dei-corsi-d2019acqua-versione-aggiornata-2016
Implementazione della Direttiva 2000/60/CE. Analisi e valutazione degli aspetti idromorfologici. Versione 1.1. https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00010100/10146-analisi-e-valutazione-degli-aspetti-idromorfologici-agosto-2011.pdf
RINALDI M., BELLETTI B., COMITI F., MAO L., NARDI L., BUSSETTINI M., con il contributo di VEZZA P. (2015). Sistema di rilevamento e classificazione delle Unità Morfologiche dei corsi d’acqua (SUM). ISPRA, Manuali e linee guida, 122/2015. Roma, aprile 2015: https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/sum-sistema-di-rilevamento-e-classificazione-delle-unita-morfologiche-dei-corsi-dacqua