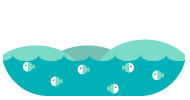La Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (Water Framework Directive - WFD o Direttiva Quadro Acque - DQA), che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di gestione e tutela delle acque interne superficiali, di transizione, costiere e sotterranee è stata recepita in Italia con il D.Lgs 152/06.
La Direttiva specifica le norme per impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici dell’Unione europea e per conseguire un «buono stato» dei fiumi, dei laghi e delle acque sotterranee in Europa entro il 2015.
Tutti i dati sulle reti e sulla classificazione dei corpi idrici in Piemonte sono visualizzabili e consultabili sul Geoportale di Arpa Piemonte.
In particolare, ciò prevede di:
- proteggere tutte le forme di acqua (superficiali, sotterranee, interne e di transizione);
- ripristinare gli ecosistemi in e intorno a questi corpi d’acqua;
- ridurre l’inquinamento nei corpi idrici;
- garantire un uso sostenibile delle acque da parte di individui e imprese.
Riportiamo di seguito le definizioni di:
Acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee; le acque di transizione e le acque costiere.
Acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo.
Acque interne: tutte le acque superficiali, correnti o stagnanti.
Acque di transizione: le acque vicino alle foci dei fiumi, che sono parzialmente di natura salina ma contengono consistenti flussi di acqua dolce.
La normativa delega chiare responsabilità alle autorità nazionali, che hanno l’obbligo di:
- individuare i singoli bacini idrografici presenti sul loro territorio, ovvero le aree territoriali circostanti che sfociano in specifici sistemi fluviali;
- designare le autorità che gestiscono questi bacini in linea con le norme dell’Unione;
- analizzare le caratteristiche di ciascun bacino idrografico e stabilire condizioni di riferimento per ogni tipologia di corpo idrico per qualificarne lo stato;
- analizzare l’impatto delle attività umane e una valutazione economica dell’utilizzo idrico;
- monitorare lo stato delle acque in ciascun bacino;
- registrare le aree protette, come quelle utilizzate per l’acqua potabile, che richiedono particolare attenzione;
- produrre e mettere in atto «piani di gestione dei bacini idrografici», per evitare il deterioramento delle acque superficiali, proteggere e migliorare le acque sotterranee e preservare le aree protette;
- garantire che il costo dei servizi idrici sia recuperato, in modo che le risorse siano utilizzate in modo efficiente e chi inquina paga;
- fornire informazioni e consentire una consultazione pubblica dei loro piani di gestione dei bacini idrografici.
Corpi idrici
Il Corpo Idrico è l’oggetto gestionale al quale è riferita la classificazione dello stato di qualità, le misure di tutela e di risanamento, la caratterizzazione quali-quantitativa delle pressioni antropiche che possono generare impatti sulla qualità chimico-fisica delle acque, delle comunità biologiche e dell’assetto idromorfologico.
Un corpo idrico è un elemento distinto e significativo, individuato sulla base delle pressioni antropiche, dello stato di qualità, delle caratteristiche naturali e omogenee per quanto riguarda gli aspetti connessi al clima, alla geologia e al rilievo, all’interno delle quali gli ecosistemi di acqua dolce dovrebbero presentare una limitata variabilità per le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, cosicché quello che viene considerato un unico fiume è distinto in più corpi idrici.
Analogamente sono individuati più corpi idrici per le acque sotterranee, dai tecnici chiamati GWB o groundwater bodies.
In Piemonte sono stati individuati 598 corpi idrici fluviali, 37 corpi idrici lacustri e 36 corpi idrici sotterranei (16 superficiali, 6 profondi e 14 montano-collinari).
Reti di monitoraggio
Le reti di monitoraggio sono specifiche per ogni tipologia di corpo idrico e sono composte da più sottoreti destinate a raccogliere informazioni diverse al fine di ottimizzare lo sforzo di campionamento ed analisi, ridurre le ridondanze e mantenere la significatività delle informazioni raccolte.
Il periodo di monitoraggio al termine del quale si procede alla valutazione della qualità dei corpi idrici è di sei anni, suddiviso in due trienni nei quali viene monitorata l'intera rete base.
La rete base è stabile nella sua composizione negli anni e comprende corpi idrici sottoposti a monitoraggio periodico e costante, comprende anche siti di riferimento per la loro alta qualità ambientale.
La rete aggiuntiva è monitorata un solo anno nel periodo di monitoraggio al fine di convalidare i dati di raggruppamenti di corpi idrici al fine della classificazione del loro stato di qualità.
Vi è poi una rete nucleo che comprende parte dei punti di monitoraggio della rete base utili per avere i dati di condizioni molto vicine alla naturalità come i siti di riferimento o rappresentativi della presenza di diffusa attività antropica.
Monitoraggio
I corpi idrici possono essere sottoposti a 3 tipologie di monitoraggio: Sorveglianza, Operativo e di Indagine per specifici approfondimenti.
Il monitoraggio di sorveglianza si applica a corpi idrici classificati non a rischio o probabilmente a rischio e ha come obiettivo di convalidare la valutazione delle pressioni e di osservare le variazioni alungo termine dello stato di qualità degli stessi.
Il monitoraggio operativo è realizzato per stabilire lo stato dei corpi idrici identificati a rischio di non soddisfare gli obiettivi ambientali della direttiva quadro e per valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi idrici risultante dai programmi di misure di tutela e salvaguardia, a più breve termine.
Il monitoraggio di sorveglianza viene effettuato su corpi idrici ove è presente un impatto antropico, rispetto al quale è necessario valutare più in dettaglio gli specifici effetti su lungo termine.
Ogni tipo di monitoraggio prevede uno specifico elenco di parametri da monitorare, in parte sovrapponibile ed in parte specifico per le particolarità del sito o delle pressioni o degli impatti individuati.
Per chiarire le differenze tra monitoraggio di sorveglianza e operativo si può dire che nel monitoraggio di sorveglianza si monitorano tutte le componenti e in quello operativo solo quelle strettamente connesse alle pressioni responsabili dell’impatto.
Raramente un corpo idrico è sottoposto ad una sola pressione o si riesce ad individuare una relazione univoca tra una pressione ed una componente da monitorare; quindi, anche nel caso di monitoraggio operativo ci saranno più componenti da monitorare, tuttavia, laddove il problema ambientale è noto o il non raggiungimento degli obiettivi è prevalentemente connesso al superamento degli standard di qualità europea, il monitoraggio operativo consente comunque di ridurre le componenti da monitorare.
Per i corpi idrici a rischio, dove è prevista l’adozione di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, il monitoraggio operativo è finalizzato a verificarne l’efficacia
Parametri di classificazione
I diversi tipi di monitoraggio sono progettati in modo da minimizzare lo sforzo di campionamento ed analisi, massimizzando al contempo l'informazione utile e pertinente per la conoscenza dello stato dei corpi idrici nei diversi luoghi, momenti e contesti ambientali, quindi non tutti i parametri da monitorare sono raccolti su tutti i siti, si applicano dei criteri di selezione in modo da calibrare il diverso tipo di monitoraggio sul rischio effettivo di riscontrare i contaminati, sulla possibilità tecnica di effettuare i rilievi o sulla significatività del dato.
In generale, quindi, su tutti i corpi idrici è applicato un protocollo analitico che comprende parametri chimico fisici generali, mentre i contaminanti sono determinati su un sottoinsieme di corpi idrici, come sopra spiegato, in base alla tipologia di monitoraggio, all’analisi delle pressioni e alla valutazione dei dati di monitoraggio del monitoraggio precedente.
Classificazione
Per ogni componente monitorata le norme definiscono dei criteri di valutazione e classificazione, abbiamo quindi delle classificazioni di qualità per le singole componenti fisico-chimiche, biologiche e idro-morfologiche, che concorrono alla classificazione finale della qualità dei corpi idrici, dato valido per valutare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva quadro.
Tale classificazione finale si attesta sul valore peggiore riscontrato nel periodo di monitoraggio componendo i diversi indicatori e sottoindici, che a loro volta, se sono calcolati su più componenti, si attestano sul valore peggiore.