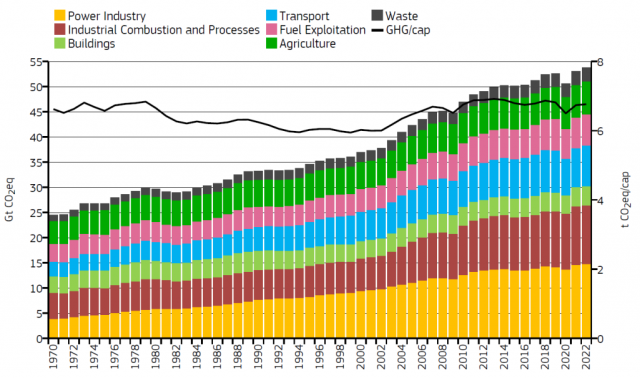Precipitazioni intense Pasqua 2024
Il mese di marzo 2024 si è contraddistinto per le frequenti e abbondanti precipitazioni sul nordovest, con un susseguirsi di onde cicloniche abbastanza serrato. L’ultima decade ha infine visto il progressivo espandersi di una depressione di matrice nord Atlantica e il protrarsi di una profonda saccatura fin sul Mediterraneo occidentale, configurazione che ha guidato diversi sistemi frontali verso le Alpi, sospinti da intensi flussi sud-occidentali in quota. La posizione della corrente a getto a latitudini molto basse a partire dal 29 marzo e l’intensificarsi del flusso meridionale in tutta la troposfera, ha portato anche all’irruzione di polvere sahariana fino all’Europa centrale, poi depositatasi durante le precipitazioni sia liquide che solide avvenute nel fine settimana pasquale. La sua sospensione in aria ha caratterizzato i cieli gialli di sabato 30 marzo, e poi la successiva deposizione sulle Alpi ha determinato la formazione di uno strato di neve rossa ben visibile. I successivi passaggi frontali e le schiarite, soprattutto di Pasqua e Pasquetta, hanno dato forma ad un evento misto tra puramente avvettivo-orografico in alcune sue fasi, a spiccatamente convettivo, con temporali a cella singola sabato pomeriggio, seguiti da una forte convergenza sulle pianure nord-orientali e la formazione di una squall line1 in rapido movimento verso est, seguiti da temporali più diffusi nella sera di domenica, e infine anche di tipo grandinigeno nel pomeriggio sera del lunedì di Pasquetta. Gli intensi apporti pluviometrici hanno determinato incrementi dei corsi d’acqua generalmente moderati, ma localmente elevati nel reticolo idrografico secondario. Le zone più colpite sono state inizialmente nel Nord del Piemonte nella serata di sabato e si sono allargate al Sud del Piemonte, in particolare nel Cuneese, nell’ultima fase tra domenica sera e lunedì mattina. Nel nord della Regione, in Valle Strona in particolare, si è altresì verificata una frana che ha interessato in due punti la viabilità provinciale e l’area di deposito ha lambito un’abitazione privata. La perturbazione, unita ad uno zero termico stabilmente intorno ai 2000-2200 m, ha portato abbondanti nevicate sulle Alpi, con neve però solo fino ai 1500 m e con densità elevata. Il pericolo valanghe ha raggiunto verso fine evento il livello massimo, 5-molto forte, in concomitanza con l’attività valanghiva spontanea più diffusa.
Per maggiori dettagli e approfondimenti consulta la relazione di evento
Nevicate 2-4 e 9-11 marzo 2024
Dopo una seconda, decade di febbraio che ha visto la ricorrente presenza di un anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale, la situazione sinottica a scala europea è profondamente mutata a partire dall’ultima decade di febbraio, con una configurazione meteorologica in cui le aree di alta pressione risultavano presenti sull’Oceano Atlantico e sull’Anatolia orientale e si è creato quindi un canale per la discesa delle depressioni di matrice artica e nordatlantica. Tale fatto ha determinato la formazione di una prima depressione che ha interessato l’Europa centrale e il Piemonte tra il 26 e il 29 febbraio, e una successiva area depressionaria nei primi giorni di marzo; da quest’ultima si è poi isolato un minimo barico secondario strutturato a tutte le quote, che è progredito lentamente tra sabato 2 e domenica 3 marzo dal Golfo del Leone verso la Costa Azzurra, causando una cospicua avvezione umida da est, sudest sul Piemonte stesso. Il progressivo calo dello zero termico ha portato nevicate fino a 600-800 m di quota a seconda dei settori, con cumulate giornaliere di precipitazione comprese tra 50 e 180 mm il 3 marzo 2024. I fenomeni precipitativi sono stati più intensi su tutta la fascia pedemontana piemontese e sulle zone pianeggianti adiacenti, che sono stati i settori maggiormente interessati dalla risalita delle masse di aria umida dai quadranti orientali in prossimità di Alpi e Appennini. Un secondo episodio di tempo perturbato diffuso si è verificato tra sabato 9 marzo e domenica 10 marzo quando un profondo minimo depressionario presente sul Golfo di Biscaglia ha convogliato masse di aria umida verso il Piemonte con precipitazioni diffuse tra la serata del 9 e la mattinata del 10 marzo. In questa occasione, la quota delle nevicate, mediamente compresa tra gli 800 e i 1000 m, è scesa anche fino a 300-400 m sul basso Cuneese. Le nevicate abbondanti del fine settimana si sono sommate ai quantitativi importanti caduti durante il fine settimana precedente, innescando un rischio valanghe pronunciato su quasi tutte le zone alpine piemontesi, una allerta di livello arancione che su Alpi Pennine, Lepontine e Graie settentrionali si è protratta fino a lunedì 11 marzo
Per maggiori dettagli e approfondimenti consulta la relazione di evento
Evento del 29-30 giugno 2024
Nel corso della giornata di sabato 29 giugno 2024, una circolazione depressionaria in arrivo dalla Penisola Iberica ha eroso il bordo occidentale di un promontorio di alta pressione nordafricana che si estendeva su tutta la penisola italiana e che, fino ad allora, stava determinando condizioni in gran parte stabili, con temperature massime che in pianura erano state localmente sui 32-34 °C nella giornata precedente. L’evoluzione a scala sinottica ha determinato un marcato aumento dell’instabilità atmosferica a partire dalle ore centrali, causata dalla decisa intensificazione delle correnti in quota dai quadranti sudoccidentali e, negli strati più bassi dell’atmosfera, prevalentemente da sud-sudest, in concomitanza ad infiltrazioni di aria più fresca in quota. I fenomeni più persistenti hanno interessato le zone di media e bassa valle nordoccidentali e settentrionali della regione e la fascia pedemontana adiacente, per interazione dei flussi instabili con l’orografia. La rigenerazione dei temporali è avvenuta per più ore sulle stesse zone, anche a causa dalla presenza del promontorio di alta pressione ad est che non ha favorito un movimento più rapido del sistema perturbato. Precipitazioni abbondanti si sono verificate sulla fascia alpina soprattutto tra Alpi Graie e Lepontine. In particolare, sono stati registrati valori di pioggia cumulata anche superiori ai 150 mm nelle valli di Lanzo, in valle Orco e in valle Anzasca. Nella stazione di Noasca (TO) i valori massimi cumulati su 1, 3 e 6 ore corrispondono a tempi di ritorno di oltre 200 anni. Anche le precipitazioni registrate presso la stazione di Alpe Veglia (VB) risultano statisticamente significative: i valori massimi cumulati per le durate di 3 e 6 ore corrispondono rispettivamente a tempi di ritorno di 100 e 200 anni. I primi consistenti innalzamenti dei corsi d’acqua si sono verificati nelle valli di Lanzo nella serata di sabato: la Stura di Valgrande a Cantoira (TO) e la Stura di Lanzo a Mezzenile (TO) hanno superato repentinamente la soglia di pericolo raggiungendo il colmo alle 19:00 UTC (21:00 locali). Nelle stesse ore, il torrente Orco ha superato il livello di pericolo in corrispondenza della sezione di Spineto (TO). A valle, il colmo di piena del torrente è transitato a San Benigno (TO) nelle prime ore di domenica, raggiungendo la soglia di guardia. A seguito delle forti precipitazioni che hanno interessato la Valle d’Aosta, la Dora Baltea a Tavagnasco (TO) ha superato il livello di guardia nelle prime ore di domenica, raggiungendo il colmo di piena alle 2:30 UTC (4:30 locali). Nella notte tra sabato e domenica anche nel Verbano ci sono stati importanti innalzamenti dei corsi d’acqua del reticolo secondario: a San Carlo (VB), il torrente Anza ha superato il livello di pericolo alle 20:30 UTC di sabato ed è tornato sotto il livello di guardia nella tarda mattinata di domenica. Anche il torrente Ovesca a Villadossola (VB) ha superato la soglia di pericolo, raggiungendo il colmo alle 00:00 UTC (2:00 locali) di domenica. Nelle stesse ore, il Toce a Domodossola (VB) ha raggiunto il livello di guardia. Tutti i contributi sono defluiti alla chiusura del bacino del Toce, dove il colmo di piena ordinaria è transitato a Candoglia (VB) alle 4:00 UTC (6:00 locali) di domenica, determinando anche un incremento del livello del Lago Maggiore. Quest’ultimo si è mantenuto al di sotto della soglia di guardia e ha registrato presso la stazione di Pallanza (VB) il livello massimo di 4,7 metri alle 17:00 UTC (19:00 locali) di domenica. Le piogge intense hanno anche determinato l'attivazione di diversi dissesti. Le zone più colpite sono state quelle comprese tra le Valli di Lanzo, le valli Orco e Soana in provincia di Torino; le valli Anzasca, Sesia e Devero nel nord Piemonte.
Per maggiori dettagli e approfondimenti consulta la relazione di evento
Temporali del 2 agosto 2024
Nel corso della giornata di venerdì 2 agosto 2024 il bordo settentrionale dell'alta pressione di matrice subtropicale presente in area mediterranea ha subito una lieve flessione a ridosso del nordovest italiano a causa del transito di un’ondulazione atlantica accompagnata da masse d’aria relativamente più fresche in quota. Il transito di aria più fredda in quota ha determinato un marcato aumento dell’instabilità atmosferica. Questi fattori, uniti alle condizioni preesistenti, che hanno visto nei giorni precedenti e nella giornata di venerdì elevati valori di temperature ed umidità relativa sulle pianure, hanno determinato l’innesco di rovesci e temporali dapprima a ridosso delle vallate alpine e della fascia pedemontana adiacente (una prima supercella ha interessato la zona di Sabbia nell’alto Vercellese al primo pomeriggio) con successivo coinvolgimento dell’area collinare del Torinese; qui il temporale formatosi è risultato persistente e in estensione verso ovest e i quartieri centrali e nordorientali della città. Dal tardo pomeriggio e poi in serata i temporali hanno interessato in maniera più diffusa il Cuneese. Le precipitazioni più intense si sono registrate a Venaria Reale (TO), dove sono caduti 85,5 mm di pioggia in un’ora e 93,5 mm in tre ore: si tratta di un valore di precipitazione molto elevato, corrispondente ad un tempo di ritorno superiore ai 200 anni per l’intervallo orario e compreso tra 100 e 200 anni per quello tri-orario. Molto intense le precipitazioni anche sul centro e sulla zona settentrionale dell’abitato di Torino: le cumulate orarie registrate dalle stazioni di Torino Reiss Romoli e Torino Giardini Reali sono state, rispettivamente, pari a 66,4 mm e 77,7 mm. Abbondanti anche le precipitazioni sulla collina torinese: la stazione di Pino Torinese (TO) ha registrato 39,6 mm di pioggia cumulata in 1 ora e 78,3 mm in 3 ore. Le forti precipitazioni sono state accompagnate da grandine con chicchi di dimensioni compresi da 4 e 5 cm. Violenti temporali hanno interessato anche le pianure del Cuneese dal tardo pomeriggio. Le precipitazioni più intense sono state registrate a Saluzzo (CN) con 48,0 mm in un’ora e 63,1 mm in tre ore e a Villanova Solaro (CN) con 43,9 mm in un’ora e 60,6 mm in tre ore.
Per maggiori dettagli e approfondimenti consulta la relazione di evento
Temporali del 14 agosto 2024
Nel corso della giornata di mercoledì 14 agosto 2024, una saccatura estesa dalle Isole Britanniche alla Penisola Iberica e al Mediterraneo occidentale si muove lentamente, evolvendo verso una situazione di isolamento del minimo barico (cut-off) sul Mediterraneo. Questa configurazione sinottica determina, sul Piemonte, l’afflusso di correnti sudoccidentali umide in quota, associate a modeste infiltrazioni di aria relativamente più fresca. Tra la tarda mattinata e le ore centrali sono già attivi temporali sulle zone alpine nordoccidentali ed iniziano a innescarsi temporali lungo il confine con la Liguria. Nella prima parte del pomeriggio i temporali si fanno più intensi e diffusi, interessando anche la zona di Torino e il cuneese; il rovescio più intenso si scatena sui bacini del Chisone e del Sangone (locali picchi fino a circa 120 mm in 3 ore). La città di Torino è colpita da un violento nubifragio, accompagnato da grandine al più di medie dimensioni e non abbondante, e raffiche di vento superiori a 50-60 km/h. Le precipitazioni più intense si sono registrate a Pinerolo (TO) e Fenestrelle (TO), dove le stazioni di Talucco e Prà Catinat hanno registrato rispettivamente 117.9 mm e 96.1 mm in tre ore: si tratta di un valore di precipitazione molto elevato, corrispondente ad un tempo di ritorno superiore ai 200 anni per l’intervallo tri-orario. Violenti temporali, associati localmente a grandinate di medie dimensioni, hanno interessato anche la zona meridionale dell’abitato di Torino: la cumulata oraria registrata dalla stazione di Torino Vallere è stata di 55.4 mm. Abbondanti anche le precipitazioni sulla collina torinese: la stazione di Pino Torinese (TO) ha registrato 38.2 mm in 3 ore. Infine, temporali localmente forti si sono verificati anche nel Vercellese dove le precipitazioni più intense sono state rilevate a Borgosesia (VC), con 45.4 mm in un’ora.
Per maggiori dettagli e approfondimenti consulta la relazione di evento
Evento del 4 e 5 settembre 2024
Nel corso del pomeriggio del 4 settembre 2024, una circolazione depressionaria centrata sulle isole britanniche si è mossa verso sud facendo il suo ingresso sul Mediterraneo occidentale, causando condizioni di tempo instabile sulla nostra regione e convogliando flussi umidi dai quadranti meridionali verso il nordovest italiano. Questa configurazione sinottica ha determinato l’attivazione di rovesci e temporali sparsi sulle zone montane piemontesi che si sono progressivamente estesi al resto della regione. Nella notte tra il 4 e il 5 settembre, le correnti, di scirocco in quota e da est-sudest negli strati medio-bassi dell’atmosfera, hanno subito un deciso rinforzo e, interagendo con l’orografia piemontese, hanno causato tempo diffusamente perturbato fino al primo pomeriggio, con rovesci temporaleschi localmente molto forti e cumulate areali di precipitazione significative, soprattutto a ridosso delle vallate occidentali e nordoccidentali. Solo dalla tarda serata di giovedì 5, le condizioni di instabilità si sono attenuate sia grazie alla graduale rimonta dei valori di pressione in quota sia per il parziale ritiro dalla pianura padana del bordo orientale della circolazione depressionaria. Le precipitazioni più abbondanti nelle due giornate dell’evento si sono verificate nel Torinese, con valori cumulati superiori a 200 mm nelle valli di Lanzo e prossimi a 190 mm in val Chisone. In queste aree le stazioni pluviometriche torinesi di Pietrastretta, Talucco, Balme e Perrero Germanasca hanno registrato, per diverse durate, valori massimi con tempi di ritorno superiori a 200 anni. A nord della regione, nel Verbano e nell’alto Vercellese, sono stati osservati 150-160 mm totali, mentre nel Cuneese, al confine con la Liguria, le precipitazioni hanno raggiunto gli 80 mm. Decisamente più contenuti gli apporti pluviometrici sulle pianure. Per quanto riguarda il reticolo fluviale, incrementi significativi sono stati registrati nella mattina del 5 settembre per i corsi d’acqua montani e pedemontani occidentali e nord-occidentali. Le prime risposte hanno riguardato i torrenti Chisone e Pellice che, a Pinerolo (TO) e a Luserna San Giovanni (TO), si sono avvicinati al livello di guardia. Deflussi importanti hanno interessato anche le Valli di Lanzo: la Stura di Valgrande a Cantoira (TO) e la Stura di Lanzo a Mezzenile (TO) hanno superato il livello di pericolo e la Stura di Viù a Germagnano (TO) ha superato la soglia di guardia. A causa di questi contributi significativi da monte, la Stura di Lanzo a Lanzo Torinese (TO) ha superato il livello di guardia, iniziando poi una lenta decrescita. Un innalzamento significativo è stato registrato anche per il torrente Orco che nella sezione di Spineto (TO) ha superato il livello di pericolo in due momenti distinti della giornata. Nel Piemonte occidentale è stato registrato in mattinata anche un incremento importante per il torrente Sangone che a Trana (TO) ha superato la soglia di guardia. Nel Piemonte settentrionale, nella prima parte della giornata, il torrente Anza ha superato a Vanzone con San Carlo (VB) il livello di pericolo e il fiume Sesia ha superato a Campertogno (BI) la soglia di guardia. Le piene che hanno interessato nella mattina di giovedì 5 gli affluenti torinesi, in sinistra idrografica, del fiume Po hanno determinato nel pomeriggio un incremento rilevante dei livelli del Po in alcune sezioni a valle di Torino. La piena ha raggiunto in serata il colmo a San Sebastiano (TO) e a Crescentino (VC), con valori coincidenti con il livello di guardia; i livelli sono diminuiti nella notte. Nelle sezioni più a valle gli incrementi del Po sono stati contenuti e i livelli si sono mantenuti ampiamente al di sotto della soglia di guardia.
Per maggiori dettagli e approfondimenti consulta la relazione di evento
Evento dell'8 ottobre 2024
Tra le prime ore della notte del 7 ottobre 2024 e il pomeriggio del giorno successivo, l’avvicinamento di una saccatura atlantica sul Mediterraneo ha causato piogge diffuse sul Piemonte, con temporali persistenti associati a piogge molto forti sui settori appenninici ai confini con la Liguria. Mentre un fronte freddo entrava gradualmente sul Mediterraneo, il bacino tirrenicoligure e il Nord Italia erano interessati da un richiamo di masse d’aria miti e molto umide dai quadranti meridionali, associate al fronte caldo della saccatura. A sostenere i temporali persistenti sulla Liguria centrale e sulle aree piemontesi adiacenti, è stata la prolungata convergenza sul Golfo di Genova tra lo Scirocco mite e umido e la tramontana più fredda in discesa dalla Pianura Padana attraverso i valichi appenninici. Le precipitazioni più abbondanti si sono verificate nell’alessandrino, con valori cumulati superiori a 200 mm in una sola giornata. Nel Verbano sono state registrate precipitazioni comprese tra i 55 e 100 mm, mentre nel Cuneese, al confine con la Liguria, le precipitazioni hanno raggiunto cumulate superiori ai 100 mm totali. Nelle restanti zone montane la precipitazione è stata superiore ai 55 mm mentre nelle zone collinari, pedemontane e di pianura è stata inferiore a 40 mm. Nelle prime ore della mattina di martedì 8 ottobre sono stati registrati incrementi significativi sul torrente Scrivia nelle sezioni di Serravalle (AL) e Guazzora (AL), pur mantenendosi al di sotto del livello di guardia. Anche il torrente Orba ha registrato incrementi significativi nella mattina di martedì superando la soglia di guardia sia a Tiglieto (GE) che a Basaluzzo (AL); nelle due sezioni il colmo è stato raggiunto rispettivamente alle ore 06:30 UTC (08:30 locali) e 11:30 UTC (13:00 locali) per poi decrescere successivamente. A seguito del passaggio della piena dell’Orba anche la Bormida ad Alessandria, il Tanaro a Montecastello e il Po ad Isola Sant’Antonio hanno registrato incrementi significativi, pur mantenendosi al di sotto della soglia di guardia. Nella parte alta del bacino idrografico del Tanaro sono stati registrati incrementi importanti per il Corsaglia nella sezione di Frabosa Soprana (CN) dove ha raggiunto il colmo, superando la soglia di guardia, alle 11:30 UTC (13:00 locali) per poi decrescere nel primo pomeriggio. Anche il Tanaro nelle sezioni di Ponte di Nava (CN) e Piantorre (CN) ha registrato incrementi significativi, rimanendo però al di sotto del livello di guardia.
Per maggiori dettagli e approfondimenti consulta la relazione di evento
Evento dal 16 al 20 ottobre 2024
Tra mercoledì 16 e domenica 20 ottobre, precipitazioni forti e localmente molto forti hanno interessato il territorio regionale, con picchi più elevati tra le Alpi Lepontine e le Cozie settentrionali e al confine con la Liguria e la Francia. Gli accumuli più consistenti si sono verificati nel Torinese, nel Biellese e nell’alto Vercellese dove localmente sono stati registrati valori superiori ai 300 mm totali. Lungo il confine con la Liguria e con la Francia sono state localmente registrate precipitazioni cumulate superiori ai 200 mm. La prima fase della perturbazione del 16 ottobre ha interessato in particolar modo i bacini idrografici di testata della Bormida e dell’Orba a causa delle intense precipitazioni registrate in Liguria e al confine con il Piemonte, dove il pluviometro di Mallare (SV) ha registrato quasi 150 mm in 6 ore. Tra la sera del 17 e la notte del 18 ottobre si sono verificate precipitazioni particolarmente intense e diffuse su tutta la regione, alcuni pluviometri del Torinese, Biellese e Cuneese hanno registrato cumulate giornaliere superiori ai 100 mm. Tali precipitazioni e le condizioni di saturazione dei suoli hanno determinato un importante innalzamento dei livelli idrometrici nel reticolo idrografico primario e secondario. In particolare, gli affluenti principali in sinistra orografica del Po: Pellice, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Orco, Dora Baltea e Sesia hanno registrato innalzamenti significativi a partire dalle prime ore del mattino del 18 ottobre. I contributi di tali corsi d’acqua hanno determinato un incremento del livello del Po lungo tutta l’asta fluviale con il superamento della soglia di guardia in alcune sezioni a valle di Torino. Anche nel Piemonte meridionale si sono verificati incrementi significativi dei livelli idrometrici con un significativo accrescimento della portata del Tanaro; il colmo di piena si è tuttavia mantenuto al di sotto del livello di guardia lungo tutta l’asta.
Per maggiori dettagli e approfondimenti consulta la relazione di evento
Evento del 26 e 27 ottobre 2024
Tra sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre 2024, precipitazioni diffuse forti e molto forti hanno interessato il Piemonte, con picchi più elevati sulle zone al confine con la Liguria e sulle zone pedemontane comprese tra Verbano e Torinese. L’evento è stato caratterizzato dalla discesa di un minimo depressionario dall’Atlantico settentrionale verso il Mediterraneo, che si è gradualmente isolato sulla Penisola Iberica e che, nei giorni successivi, ha avuto un impatto devastante su ampie porzioni del territorio spagnolo, tra le quali la Comunità di Valencia. Il nostro territorio, tuttavia, è stato interessato solo tangenzialmente dalla prima fase di questa perturbazione, la quale è stata comunque sufficiente a causare disagi e colpire in particolar modo i bacini idrografici di testata della Bormida e dell’Orba con temporali molto forti nella giornata di sabato 26 ottobre. In queste zone si sono verificate infatti precipitazioni particolarmente intense e localizzate, anche a causa della formazione di temporali di tipo V-shape che hanno prodotto quantitativi pluviometrici mediamente compresi tra i 90 e 115 m nell’arco di due giorni, con punte sul territorio ligure di 207 mm a Mallare (SV), 209 mm Rossiglione (GE) e 194 mm Cairo Montenotte (SV). Anche nel nord del Piemonte si segnalano, tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, valori medi di pioggia oltre i 100 mm nel bacino del Toce e di 85 mm nel Sesia, con valori massimi puntuali di 210 mm a Candoglia (VB), 167 mm al Santuario di Oropa e 162 mm a Paino Audi (TO). Questi quantitativi di pioggia, uniti alle condizioni di saturazione dei suoli, hanno determinato dal pomeriggio di sabato 26 ottobre importanti onde di piena sui corsi d’acqua del reticolo principale e secondario, con livelli idrometrici che hanno superato in alcuni casi le soglie di guardia o di pericolo. La situazione più critica ha riguardato la Bormida che ha superato il livello di pericolo a monte sul ramo della Bormida di Spigno (con livello massimo storico a Piana Crixia, SV) e a valle a Cassine (AL), anche a causa delle piene generate sugli affluenti Erro e Orba. Il Tanaro ha avuto una fortecrescita a Montecastello (AL), a valle della confluenza con la Bormida. Incrementi significativi sono stati registrati anche nel Verbano per Ovesca e Anza e nel Torinese per Orco, Stura di Lanzo e Malone. La piena del Po è transitata a Torino in criticità ordinaria mentre nelle sezioni a valle è stata superata o avvicinata la soglia di guardia a causa dei contributi degli affluenti in sinistra idrografica.
Per maggiori dettagli e approfondimenti consulta la relazione di evento