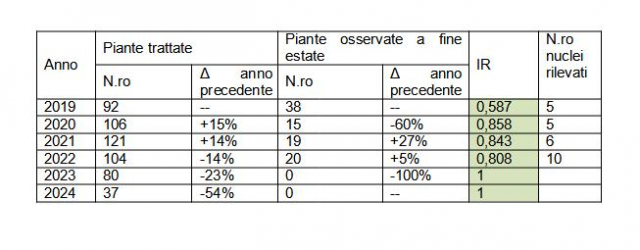Nel cuore del Piemonte, dove le dolci colline astigiane si fondono con la memoria geologica del territorio, una mostra temporanea riporta alla luce il legame profondo tra scienza, storia e natura. In occasione del quarantennale della Riserva Naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, il Museo Paleontologico di Asti ospita per la prima volta una selezione della preziosa collezione di Carlo Allioni, medico e naturalista piemontese del XVIII secolo. Una raccolta unica, che affonda le radici in una terra che già secoli fa rivelava i suoi antichi segreti ai primi studiosi di fossili.
Alle origini della paleontologia piemontese
Allioni, figura eminente del panorama scientifico settecentesco, fu tra i primi a dedicarsi allo studio sistematico dei fossili piemontesi. La sua opera più celebre in ambito paleontologico, Oryctographiae Pedemontanae Specimen (Parigi, 1757), può essere considerata la prima vera monografia sui fossili della Regione. In essa compaiono oltre 65 citazioni della “Valle d’Andona”, un’area che, oggi come allora, si conferma straordinario scrigno fossilifero FOTO 3 .
A distanza di secoli, i reperti provenienti da questa valle tornano a essere protagonisti, celebrando non solo il valore scientifico di un territorio, ma anche la straordinaria attualità del lavoro di Allioni, che già nel XVIII secolo tracciava una mappa fossile del Piemonte con metodo e rigore.
Una collezione tra storia e mistero
Il viaggio della collezione Allioni è una storia nella storia. Dopo la morte del naturalista, i suoi fossili seguirono un lungo e travagliato percorso: venduti, trasferiti, dimenticati e infine ritrovati. Il passaggio dai colli di Pecetto al Seminario di Chieri, fino al Museo Geologico Sperimentale del Club Alpino Italiano di Giaveno, è stato ricostruito grazie a documenti storici, tra cui una dattiloscritta del 1929 del botanico Oreste Mattirolo.
Oggi, grazie alla collaborazione tra il Museo di Asti e il Museo Geologico di Giaveno, parte di quel patrimonio torna accessibile al pubblico, in un allestimento che racconta non solo la scienza, ma anche l’avventura culturale di una collezione ritrovata.
Un’eredità scientifica tra due secoli
Carlo Allioni, nato a Torino nel 1728 da una famiglia astigiana dalle solide radici borghesi, si laureò in medicina a soli 19 anni ma ben presto il suo interesse si ampliò verso le scienze naturali, in particolare la botanica, la mineralogia e la paleontologia, discipline che all’epoca si stavano appena strutturando in ambiti scientifici autonomi. Venne nominato professore straordinario di Botanica all’Università di Torino nel 1760 e, tre anni più tardi, assunse la direzione dell’Orto Botanico, che trasformò in un importante centro di ricerca e catalogazione del mondo vegetale. Il suo erbario, conservato all’Università di Torino, e la Flora Pedemontana (1785) ne testimoniano l’approccio meticoloso e innovativo. Ma è forse nella corrispondenza con Linneo che meglio emerge la statura internazionale di Allioni. Un dialogo epistolare fitto, fatto di semi, libri e idee, che racconta un’Europa scientifica viva, curiosa e profondamente connessa. Le sette lettere autografe inviate da Linneo a Torino e quelle di Allioni conservate alla Linnean Society di Londra sono oggi un patrimonio storico inestimabile, che consente di ricostruire la nascita e lo sviluppo delle scienze naturali europee del XVIII secolo.
Ma la grandezza di Allioni non si limita alla botanica. La sua raccolta geologica, comprendente oltre 6.000 campioni tra minerali, rocce e fossili, è tra le più ampie e rappresentative del suo tempo. Ricevette campioni da ogni parte d’Europa, dimostrando un'intuizione precoce del concetto di comunità scientifica globale. La sua raccolta includeva anche una sezione entomologica con più di 4.000 insetti, e numerosi fossili vegetali, come litoxylon, carpolithus e foliorum impressiones, testimoniando un interesse trasversale e multidisciplinare. La sua figura incarna il passaggio tra l’erudizione enciclopedica del Settecento e la nascita della scienza moderna.
Carlo Allioni morì a Torino il 30 luglio 1804, ma la sua eredità scientifica ha attraversato due secoli, restando viva nei musei, nelle università e nei testi di riferimento. La sua figura testimonia quanto il territorio piemontese sia stato non solo teatro di scoperte naturalistiche, ma anche culla di una visione scientifica innovativa e internazionale. La riscoperta della sua collezione, oggi esposta ad Asti, non è solo un omaggio alla memoria ma è un invito a rileggere la scienza con occhi nuovi.
La paleontologia come vocazione del territorio
La mostra non è solo un omaggio al passato, ma anche un riconoscimento al ruolo che Asti continua a ricoprire nella paleontologia internazionale. Il Museo conserva una delle più importanti collezioni di fossili marini del Pliocene, con olotipi di cetacei che hanno fatto scuola nella classificazione delle specie.
Accanto ai fossili storici di Allioni, il visitatore potrà ammirare esemplari rinvenuti oggi che raccontano milioni di anni di evoluzione e di mare scomparso, in un viaggio che unisce l’emozione della scoperta alla bellezza di un paesaggio che ha ancora molto da dire.
Un progetto didattico d’eccellenza
Il percorso di valorizzazione della collezione Allioni ha coinvolto anche il mondo della scuola. Nel 2014, gli studenti dell’I.I.S. Blaise Pascal di Giaveno (To) hanno tradotto l’Oryctographiae Pedemontanae dal latino, riconnettendo descrizioni scientifiche e campioni fisici. Un lavoro rigoroso e appassionato, ribattezzato Labor Mirabilis, che dimostra come la scienza possa ancora essere fonte di stupore e di formazione profonda.
In occasione dell’inaugurazione della mostra verrà presentata questa pubblicazione in presenza dell’autore che dialogherà con il pubblico.
Una mostra per celebrare e riscoprire
L’esposizione rappresenta un’occasione preziosa per celebrare i quarant’anni dell’Area Protetta (L.R.25/03/1985) e per riscoprire, attraverso gli occhi di uno scienziato del passato, le meraviglie nascoste nel sottosuolo piemontese. Un tributo alla memoria e alla conoscenza, che invita i visitatori a guardare con curiosità al passato per comprendere meglio il presente e proteggere il futuro.
Il 30 maggio alle ore 17,00 si inaugurerà l’esposizione temporanea nelle sale didattiche del Museo dei Fossili (c.so Alfieri 381, Asti) che rimarrà aperta fino al 30 settembre 2025 negli orari di apertura del museo.
Sarà una mostra per tutti: per chi ama la scienza, per chi cerca storie da raccontare, per chi vuole conoscere meglio un territorio che da sempre custodisce sotto i suoi piedi una memoria millenaria.